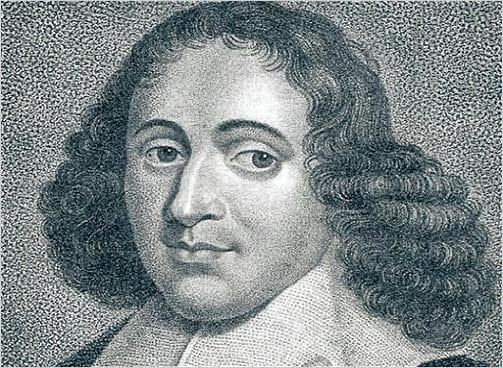Negli ultimi anni, il concetto di moral hazard è tornato al centro del dibattito economico e politico. Dalla crisi finanziaria del 2008 al tema della giustizia sociale, il moral hazard rappresenta uno dei nodi cruciali della critica al capitalismo finanziario: quando un’élite assume rischi eccessivi, ne trae vantaggi in caso di successo, ma scarica le perdite sulla collettività.
In questo articolo analizziamo cos’è il moral hazard, le sue origini, il suo impatto sulla società e le accuse rivolte alle élite economiche e politiche.
Cos’è il Moral Hazard?
Il termine moral hazard descrive una situazione in cui un individuo o un gruppo prende decisioni rischiose perché sa che, in caso di fallimento, non sarà lui a pagarne il prezzo. È un concetto chiave nella teoria economica e ha implicazioni profonde nella politica, nella finanza e nella società.
Un esempio classico è il salvataggio delle banche in crisi con denaro pubblico: se una banca assume rischi eccessivi per massimizzare i profitti e poi, in caso di collasso, viene salvata dallo Stato, i suoi dirigenti e investitori non subiscono le conseguenze delle loro azioni. Al contrario, il costo viene trasferito ai contribuenti.
L’idea di moral hazard si collega quindi a due questioni fondamentali:
- L’irresponsabilità delle élite finanziarie, che speculano senza dover rispondere delle conseguenze.
- L’ingiustizia sociale, perché le perdite vengono socializzate, mentre i profitti restano privatizzati.
Origini e sviluppi del concetto
Il concetto di moral hazard ha radici nell’economia, ma si è evoluto nel tempo. Quando il rischio viene scaricato sulla collettività – ad esempio attraverso interventi pubblici per coprire perdite private – si parla di socializzazione delle perdite.
Secondo il sociologo Niklas Luhmann, il rischio si distingue dal costo e dal pericolo:
- Il costo è un sacrificio certo e quantificabile.
- Il rischio è un possibile danno futuro derivante da una decisione.
- Il pericolo è un evento dannoso che proviene da fattori esterni, non da scelte dirette.
Un evento può essere contemporaneamente un rischio per chi lo causa e un pericolo per chi lo subisce. Ad esempio, una grande impresa può decidere di investire in un progetto ecologicamente dannoso: per l’azienda è un rischio calcolato, per l’ambiente e la società è un pericolo concreto.
Moral Hazard e responsabilità sociale
Il moral hazard è spesso associato alla mancanza di responsabilità sociale delle imprese. Il sociologo Ulrich Beck ha sottolineato come molte aziende adottino comportamenti rischiosi, scaricando i costi sulla collettività.
Un caso emblematico è lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali. Le imprese traggono profitti immediati, mentre le conseguenze – inquinamento, esaurimento delle risorse, danni alla salute – ricadono sulle generazioni future. Qui emerge la contrapposizione tra:
- Moral hazard: le aziende negano il legame tra le loro azioni e le conseguenze negative sulla società.
- Responsabilità: implica assumersi i costi delle proprie scelte, anche quando i benefici vanno ad altri.
Un esempio di comportamento responsabile è quello delle aziende che investono nella riconversione ecologica della produzione, anche se i costi immediati sono alti e i benefici incerti.
Il Caso Lehman Brothers e la Crisi del 2008
Il concetto di moral hazard ha acquisito notorietà globale con il fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre 2008. Dopo un semestre di crollo del valore azionario, la banca d’investimento statunitense ha dichiarato bancarotta, mentre il governo USA ha rifiutato di salvarla con fondi pubblici.
La decisione di non intervenire è stata motivata anche dalla volontà di non incentivare il moral hazard: se il governo avesse salvato Lehman, altre banche avrebbero potuto assumere ancora più rischi, contando su un futuro intervento pubblico.
Dopo il crollo di Lehman, il concetto di moral hazard ha dominato la stampa economica e finanziaria. Alcuni giornali hanno accusato le élite politiche e finanziarie di:
- Irresponsabilità: le banche hanno scommesso sui mercati sapendo che, in caso di perdita, il costo sarebbe stato sostenuto dai contribuenti.
- Disuguaglianza nei compensi: i dirigenti delle banche hanno ricevuto bonus milionari, indipendentemente dalle performance aziendali.
- Perdita di fiducia nel sistema: salvare le banche senza punire i responsabili avrebbe incentivato nuovi comportamenti rischiosi.
D’altra parte, chi sosteneva il salvataggio di Lehman evidenziava che:
- Il crollo della banca ha avuto conseguenze peggiori rispetto a quelle di un eventuale intervento pubblico.
- L’urgenza della crisi avrebbe dovuto prevalere sulle considerazioni morali.
Alla fine, la crisi ha alimentato una crescente indignazione pubblica, rafforzando le critiche al capitalismo finanziario.
Moral Hazard e critica alle Élite Finanziarie
Uno dei punti centrali della critica al moral hazard riguarda il legame tra élite finanziarie, politiche e il resto della società. Sulla stampa economica e generalista, l’opposizione tra:
- Banchieri e politici, accusati di proteggere i propri interessi.
- Contribuenti e cittadini comuni, costretti a pagare il prezzo delle crisi finanziarie.
Le critiche si concentrano su due aspetti principali:
- L’uso di strumenti finanziari complessi, come la cartolarizzazione dei mutui, che ha contribuito alla crisi del 2008.
- Le retribuzioni sproporzionate dei banchieri e dei politici, scollegate dai risultati economici.
Man mano che la crisi si è propagata nell’economia reale, il dibattito si è ampliato:
- La disparità di reddito è stata denunciata come segno di un sistema ingiusto.
- Alcuni analisti hanno collegato le disuguaglianze interne ai singoli paesi con squilibri globali più ampi.
- I giornali hanno iniziato a dare spazio alle proteste che chiedevano più trasparenza nel sistema bancario e una riduzione degli stipendi dei manager.
Il Moral Hazard e la crisi del Capitalismo
Il concetto di moral hazard ha giocato un ruolo centrale nella critica al capitalismo finanziario. L’irresponsabilità delle élite economiche e politiche, unita alla socializzazione delle perdite, ha alimentato il risentimento sociale e le proteste.
Le domande chiave rimangono aperte:
- È giusto che i profitti siano privatizzati mentre le perdite vengono scaricate sui cittadini?
- Come si può bilanciare la necessità di salvare l’economia con la responsabilità degli attori finanziari?
- È possibile regolamentare il sistema senza creare nuovi problemi di moral hazard?
La crisi del 2008 ha mostrato i pericoli di un capitalismo senza regole, ma ha anche riacceso il dibattito sulla distribuzione della ricchezza e sulla giustizia economica. Il tema del moral hazard non riguarda solo la finanza, ma il futuro del modello economico in cui viviamo.