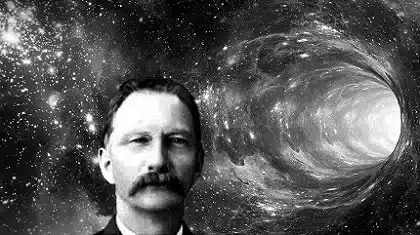Dopo mesi di discussioni, ritardi e costi di produzione alle stelle, il nuovo live-action di Biancaneve è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche. La rivisitazione della celebre fiaba, diretta da Marc Webb e con Rachel Zegler e Gal Gadot nei panni delle due protagoniste, ha scatenato reazioni contrastanti. Molti fan della versione Disney del 1937 hanno criticato le scelte narrative e di casting, accusando il film di essere troppo influenzato da una visione moderna e “politicamente corretta”.
Le domande non sono mancate: perché i sette nani sono spariti dal titolo? Che fine ha fatto il principe? E il bacio sulla bara di cristallo? Per alcuni, il film ha sacrificato la magia dell’originale per adattarsi ai tempi, mentre altri sostengono che, in realtà, la storia di Biancaneve è sempre stata più oscura e controversa di quanto si creda.
Da dove viene davvero Biancaneve?
Per comprendere appieno le differenze tra le varie versioni della storia, bisogna risalire alle sue origini. Le fiabe, per loro natura, sono racconti tramandati oralmente e modificati nel corso del tempo. La versione che conosciamo oggi di Biancaneve è stata codificata dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm all’inizio del XIX secolo, quando raccolsero e rielaborarono centinaia di storie della tradizione popolare tedesca nella loro celebre raccolta Fiabe del Focolare (1812-1814).
Tuttavia, l’immagine di Biancaneve impressa nella memoria collettiva è quella del classico animato Disney del 1937, il primo lungometraggio a colori della storia del cinema. Con il suo vestito giallo e blu, il canto melodioso e il carattere dolce, la Biancaneve di Disney è diventata l’icona definitiva della principessa delle fiabe. Ed è proprio con questo modello che la nuova versione con Rachel Zegler deve fare i conti.
Una fiaba oscura
Chi pensa che il live-action abbia “rovinato” la storia originale potrebbe rimanere sorpreso nel riscoprire la versione scritta dai Grimm, che contiene elementi ben più crudi di quelli oggi considerati accettabili in un film per famiglie.
Nella prima versione della fiaba, risalente al 1812, la principale antagonista non è una matrigna, ma la madre biologica di Biancaneve, una figura ossessionata dalla bellezza della figlia e disposta a ucciderla per rimanere la più bella del reame. Nel 1857, però, i fratelli Grimm decisero di rivedere il racconto, trasformando la madre nella matrigna malvagia per rendere la storia più digeribile per il pubblico dell’epoca.
Un altro dettaglio inquietante è l’età della protagonista: Biancaneve ha solo sette anni. Eppure, la Regina la vede già come una minaccia, dimostrando come la rivalità femminile nella fiaba sia portata all’estremo. Il suo piano omicida è altrettanto brutale: ordina al cacciatore di uccidere la bambina nel bosco e di portarle i suoi polmoni e il suo fegato come prova dell’omicidio. Non solo: intende mangiarli, un dettaglio raccapricciante eliminato nelle versioni successive.
Il cacciatore, però, non se la sente di eseguire l’ordine e lascia fuggire Biancaneve. Così, la Regina tenta più volte di ucciderla personalmente: prima con un corpetto troppo stretto, poi con un pettine avvelenato e infine con la famosa mela avvelenata, che riesce a portare a termine il suo intento.
Un “principe azzurro” inquietante
Anche il ruolo del principe nella fiaba originale è decisamente meno romantico di quanto si possa pensare. Dopo aver avvelenato Biancaneve, la Regina crede di aver vinto e la fanciulla viene riposta in una bara di cristallo dai sette nani, che non vogliono seppellirla perché troppo bella.
A questo punto arriva il principe, che non ha mai incontrato Biancaneve prima d’ora, ma se ne innamora mentre giace apparentemente morta. Senza alcun contatto o relazione precedente, chiede ai nani di regalargli il suo corpo, dicendo di volerla “onorare come la cosa più cara al mondo”.
Nessun bacio magico, nessun gesto d’amore: Biancaneve si risveglia per caso, perché un servo del principe inciampa mentre trasporta la bara e il pezzo di mela avvelenata esce dalla sua gola. Senza troppe domande su cosa sia successo, il principe le chiede immediatamente di sposarlo. Un corteggiamento decisamente fulmineo, per usare un eufemismo.
E il finale? Se nella versione Disney la Regina precipita da una scogliera, nella fiaba dei Grimm viene punita in modo ben più crudele: viene costretta a indossare scarpe di ferro rovente e a danzare fino alla morte.
Biancaneve tra passato e presente
Quando Walt Disney decise di trasformare questa storia in un film d’animazione, compì un’opera di adattamento simile a quella che oggi si contesta ai live-action. Il cartone del 1937 eliminò i dettagli più macabri e diede a Biancaneve un ruolo più passivo, ma rese la fiaba accessibile a un pubblico più ampio, soprattutto ai bambini.
Nonostante le sue modifiche, Disney mantenne il senso di mistero e paura tipico delle fiabe, con scene iconiche come la fuga nel bosco o la trasformazione della Regina. Questo dimostra che, per funzionare, le fiabe devono sempre essere reinterpretate in base al loro tempo.

Il live-action: una Biancaneve diversa
Il nuovo film del 2025 ha deciso di aggiornare nuovamente la storia, rendendola più in linea con la sensibilità contemporanea.
Alcune delle principali modifiche includono:
-
Un’eroina più indipendente: Biancaneve non è più una ragazza in attesa di essere salvata, ma una protagonista attiva nel suo destino.
-
Un nuovo interesse amoroso: Il classico principe è stato sostituito da un personaggio inedito, Jonathan, che rappresenta un legame più realistico e meno forzato.
-
L’assenza del bacio sulla bara: Una delle scene più discusse del classico animato è stata eliminata, coerentemente con l’idea che il consenso debba essere esplicito.
-
Una rappresentazione più inclusiva: Il film ha scelto di modificare il ruolo dei sette nani per evitare stereotipi legati alla disabilità.
Se questa nuova versione piacerà al pubblico, è ancora presto per dirlo. Ciò che è certo, però, è che ogni epoca riscrive le fiabe a modo suo, e Biancaneve continua a essere una storia capace di far discutere, emozionare e, soprattutto, evolversi nel tempo.