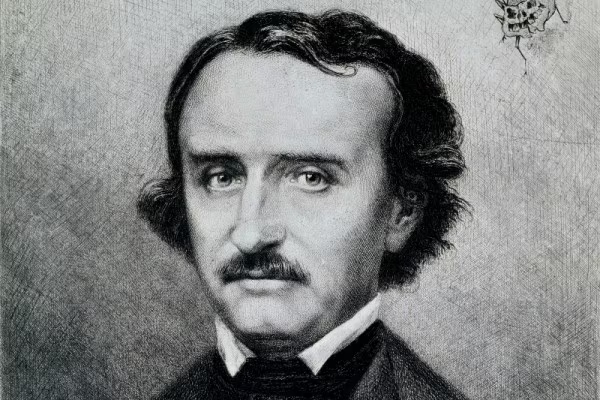Il 14 aprile 2025 sei donne hanno viaggiato nello spazio a bordo della capsula New Shepard di Blue Origin. Una missione breve, durata undici minuti, organizzata per una finalità ben precisa: promuovere il turismo spaziale. A bordo c’erano volti noti e influenti. Katy Perry, pop star di fama mondiale, ha intonato “What a Wonderful World” mentre osservava la Terra dall’alto, portando con sé un piccolo fiore di margherita, simbolo della figlia Daisy. Con lei c’erano la giornalista di CBS Gayle King, Lauren Sanchez – fidanzata di Jeff Bezos e promotrice della missione – l’ex scienziata NASA Aisha Bowe, l’attivista Kerianne Flynn e l’astrofisica Amanda Nguyen.
Tutte e sei le partecipanti erano donne, e tutte hanno sperimentato per qualche minuto l’assenza di gravità oltre la linea di Kármán, il confine convenzionale tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. Ma oltre alle immagini spettacolari e ai titoli celebrativi, la missione ha sollevato anche polemiche e riflessioni.
Tra le critiche principali, quella sull’impatto ambientale: ogni lancio suborbitale produce fino a 200 tonnellate di CO₂. In un’epoca in cui il cambiamento climatico è una delle emergenze globali più gravi, non è un dato trascurabile. A questo si aggiunge una domanda più etica che scientifica: ha senso usare razzi e carburante per permettere a miliardari e celebrità di fare un “salto nello spazio”? L’attrice Olivia Wilde lo ha definito “un esercizio di marketing a sei zeri”, mentre altri lo vedono come un gioco per ricchi mascherato da impresa pionieristica.
Il fatto che fossero tutte donne, poi, è stato presentato come un gesto di empowerment, una rivincita storica. Ma proprio qui si apre il paragone con un gruppo di donne che, oltre sessant’anni fa, lo spazio non hanno nemmeno potuto sfiorarlo. Parliamo delle Mercury 13.
Mercury 13: le pioniere dimenticate dello spazio
Tra il 1960 e il 1961, tredici pilote statunitensi – tutte civili, tutte esperte, alcune con più ore di volo di molti colleghi maschi – furono selezionate per partecipare privatamente a un programma di test ispirato al progetto Mercury della NASA. Le organizzatrici, capeggiate dal medico aerospaziale William Randolph Lovelace, volevano dimostrare che anche le donne erano fisicamente e mentalmente adatte per lo spazio.

Tra queste c’era Geraldyn “Jerrie” Cobb, una delle pilote più competenti dell’epoca. Superò tutti i test, in alcuni casi con risultati migliori di quelli degli astronauti uomini. Altre partecipanti – come Wally Funk, che a distanza di decenni sarebbe andata nello spazio con Jeff Bezos nel 2021 – dimostrarono resistenza, lucidità, prontezza di riflessi.
Eppure, nonostante le prestazioni eccellenti, il programma fu bloccato. La motivazione ufficiale? Le donne non potevano accedere al corpo militare, prerequisito allora richiesto per diventare astronauti NASA. Nessuna delle Mercury 13 volò nello spazio. Furono cancellate dalla storia dell’esplorazione spaziale ufficiale per un solo motivo: il loro genere.
Il Congresso si occupò del caso nel 1962. Tra i testimoni contrari all’inclusione delle donne nei programmi spaziali ci fu anche John Glenn, il primo americano a orbitare attorno alla Terra, che dichiarò: “L’uomo va nello spazio perché è parte del ruolo che ha sempre avuto.” Una frase che, oggi, suona come una condanna scolpita nel tempo.
Ecco perché l’equipaggio tutto femminile del 2025, sebbene accolto con entusiasmo da molti, ha un retrogusto amaro. È il segno che ci sono voluti oltre sessant’anni perché un gruppo di donne potesse essere al centro di una missione spaziale – anche se si è trattato di un volo turistico e non di una missione scientifica. È una conquista? Forse. Ma è anche uno specchio di una realtà in cui il riconoscimento passa per i soldi e la fama, non per il merito.
Le Mercury 13 volevano fare la storia con la competenza. Le sei donne del volo Blue Origin del 2025 ci sono riuscite con l’influenza e il capitale. Il confronto è inevitabile.
Il prezzo del progresso: tra empowerment e impatto ambientale
E poi c’è l’ambiente. Ogni lancio suborbitale, come quello della New Shepard, ha un costo climatico altissimo: centinaia di tonnellate di CO₂ per pochi minuti nello spazio. A differenza dei voli commerciali o delle missioni scientifiche con obiettivi concreti, questi viaggi non portano nuove scoperte, non migliorano la vita sulla Terra, non aprono nuove frontiere. Sono viaggi simbolici, esperienze esclusive per chi può permettersele.
La domanda allora è: a che serve tutto questo? Serve davvero a promuovere l’inclusione, come ha dichiarato Lauren Sanchez, o è solo un modo elegante per vendere biglietti milionari e migliorare l’immagine di chi finanzia queste missioni?
Forse oggi, più che mai, parlare di spazio vuol dire anche parlare di scelte. Di chi ha avuto il diritto di andarci e chi no. Di chi ci va oggi e con quali motivazioni. E di quanto siamo disposti a inquinare per un selfie a gravità zero.
Il 14 aprile 2025 sei donne hanno guardato la Terra da lontano. Una vista meravigliosa, che le Mercury 13 non hanno mai avuto. Forse è giusto celebrare questo traguardo. Ma non dimentichiamo chi è rimasta a terra, non per mancanza di capacità, ma per mancanza di permesso. E non dimentichiamo che ogni razzo lanciato oggi ci allontana un po’ di più da quel pianeta che – per ora – è l’unico che abbiamo.