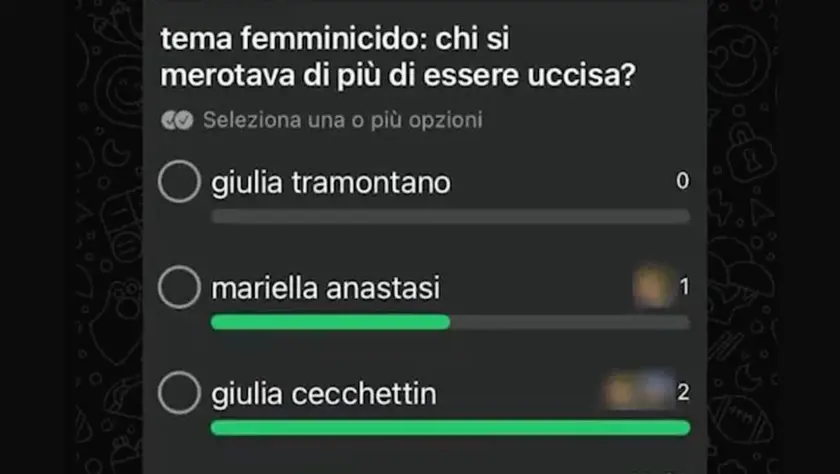Nella vita di una donna si presenta un dualismo su cui spesso si sorvola lasciandolo cadere nel dimenticatoio delle cose poco rilevanti: esser sante o essere streghe? Venire ammirate per le proprie azioni, considerate pure e di buon cuore, o venire considerate di poca affidabilità e con intenzioni maligne?
Lo storico delle religioni Marcello Craveri (1914-2002) affronta questo divario nel suo saggio Sante e Streghe. Biografie e documenti dal XIV al XVII secolo (1980), rivoluzionando totalmente la visione di queste due figure così apparentemente agli opposti, e proponendoci un quesito fondamentale: e se queste due figure, nel concreto, fossero solo la rappresentazione della stessa fantasia morbosa di teologi e inquisitori?
Lo scopo del saggio diventa quindi un’aperta sfida alla visione manichea tradizionale, e dimostra che il confine tracciato dalla società tra santità e stregoneria è stato molto labile nella storia, aprendosi all’ipotesi che medesime manifestazioni e comportamenti femminili venissero interpretati ora come segni di santità, ora come prove di stregoneria.
Tramite documenti originali dell’epoca, Craveri fa emergere le somiglianze e le contraddizioni di queste due figure tormentate, mostrando come le sante e le streghe non fossero affatto due “specie” di donne differenti, ma fenomeni con radici comuni nella cultura e nella religiosità del tempo.
Possiamo quindi, con l’analisi di questo saggio da donne, porci un quesito che magari ci è passato di mente qualche volta nella vita: ma noi saremmo state sante o streghe?
Il confine fin troppo sottile
Uno dei punti essenziali di Sante e Streghe è il pensare che santità e stregoneria fossero lungi dall’essere poli opposti, e che originariamente potessero coincidere qualora s’identifichino con la magia, considerata fase primitiva di ogni religione.
Non solo nel Medioevo (nella cui giustificazione si ricade spesso fraintendendo quell’epoca come periodo buio dell’uomo), ma anche in età moderna stessi fenomeni potevano attribuire alla donna l’etichetta di santa o di strega. I fenomeni in questione potevano essere dei più svariati: visioni estatiche, trance mistiche, profezie, guarigioni miracolose, contatti con entità soprannaturali. Gli elementi appena citati, agli occhi di un lettore moderno, possono essere disorientanti perché appaiono giustificati sia nel caso di santità sia nel caso di stregoneria.
Proprio questo disorientamento è ciò che Craveri evidenzia, rendendo chiaro come spesso fosse solo una questione di contesto, fortuna o protezioni giuste a determinare il destino di queste donne messe a processo: nel caso di una giusta alleanza ecclesiastica e sociale, le loro esperienze sarebbero state interpretate come doni divini e venerate; in caso contrario, le stesse esperienze erano ciò che marchiava la donna come veneratrice del demonio per poi essere condotta al rogo.
Le sante e le streghe: solo una superstizione del loro tempo?
Si prenda d’esempio Caterina Benincasa, ovvero santa Caterina da Siena. Fin da piccola, riportò di aver avuto visioni, estasi mistiche, e perfino fenomeni corporei (le stimmate invisibili), in aggiunta a rapporti carnali a livello spirituale con Cristo. Oggi definiremmo questi fenomeni come paranormali, tuttavia tali doti le valsero la fama di santità e un ruolo assai influente nel suo tempo. Nel suo saggio, Craveri cita il caso di diverse Caterine: oltre a Caterina da Siena, appaiono donne quali Caterina Fieschi Adorno (santa Caterina da Genova) e Caterina Mattei da Racconigi, soprannominata la masca di Dio (ovvero, la strega di Dio) perché manifestava fenomeni estatici e per questo venerata come beata.

In totale opposizione, un’altra donna omonima, Caterina de’ Medici da Broni, istruita ma pur sempre di umili origini, venne condannata al rogo a Milano nel 1617 perché accusata di maleficio e stregoneria, pur mantenendo sempre gli stessi fenomeni fisici e spirituali delle sante citate in precedenza.
Si giunge, dunque, ad un vero e proprio paradosso storico: il confine tra santità e stregoneria è un confine fluido e per nulla affidabile. Le donne calunniate come streghe o venerate come sante condividevano esperienze psicologiche e spirituali simili, ma agli occhi delle persone appaiono due figure impossibili da comparare. Ciò suggerisce cje entrambe le figure affondano le radici nella medesima cultura superstiziosa cristiana, pronta a vedere il miracoloso o il diaboli in manifestazioni che oggi forse riconosceremo come stati alterati di coscienza o disturbi psicologici.
Non a caso, Craveri (si tenga a mente che si prendessero in considerazione gli studi psicologici dell’epoca in cui è stata scritta l’opera) parla apertamente di “identica patologia isterica” che colpiva sia sante che streghe. Che il mito dell’isteria sia stato sfatato è ormai noto, ma ciò non toglie che si rifaccia all’idea che fossero donne di per sé affette da disagi psichici che divennero vittime dell’interpretazione superstiziosa che la società cristiana dava ai loro sintomi.
Il fenomeno della santità e della stregoneria femminile
La domanda che ci si pone è dunque una soltanto: come si è riuscito a costruire due figure così contrastanti sulle stesse fondamenta?
La risposta, secondo Craveri, arriva dal bisogno della Chiesa e della cultura patriarcale di quel tempo di inquadrare e controllare il comportamento femminile. Da una parte, alcune donne eccezionali vennero elevato allo status di sante: mistiche, visionarie e beate che, a patto di rimanere entro i limiti dell’ortodossia religiosa, potevano godere di autorità morale.
Ma a quale prezzo? La rinuncia completa a sé stesse, al proprio corpo, alla propria voce per sottomettersi totalmente ai dogmi e alla guida maschile.
Dall’altra parte della medaglia, la figura della strega serve come monito per chi quei limiti pretendeva di superarli.
Donne indipendenti, legate a saperi popolari o più semplicemente troppo “scomode” da poter sopportare, venivano accusate di stregoneria, torturate e condannate. A questo proposito, Craveri sottolinea come bastasse veramente poco per saltare dalla santità all’ombra del rogo: un comportamento eccentrico, una parola di troppo, una conoscenza non approvata.
Donne che volevano essere solo donne
La critica offerta dall’autore al ruolo della religione e della cultura nel plasmare la percezione femminile appare, in conclusione, molto chiara. Dalle pagine di questo saggio emerge che la Chiesa medievale e moderna, con il suo immaginario dualistico di angeli e demoni, esercitò una forte influenza nel definire cosa fosse una donna buona e cosa una donna cattiva. Si offrivano due ruoli soli e simbolici alla femminilità: la santa casta e obbediente (seguendo l’esempio emblematico e idealizzato della Vergine Maria) o la strega malvagia e ribelle (seguendo l’ombra di Eva tentatrice e delle eresiarche).
Eppure, tanto le sante quanto le streghe, nella lettura di Craveri, hanno qualcosa in comune: sono donne che cercavano invano di ritagliarsi uno spazio, di parlare, e di contare in una società che le voleva mute e sottomesse. Le due facce della stessa medaglia, usate dal potere per premiare la docilità o punire l’indipendenza, si uniscono oggi in forme che possiamo leggere come forme di pura resistenza.
Pur essendo, oggigiorno, un saggio considerato “dimenticato” o “non abbastanza importante”, la visione e l’analisi di Craveri di queste figure rimane tuttora illuminante. È un invito a superare gli stereotipi che attanagliano la donna da secoli: dietro ogni estasi e ogni sabba, risiede una donna reale, con desideri, paure e forza.
E a volte, anche una protesta silenziosa contro l’ordine stabilito.