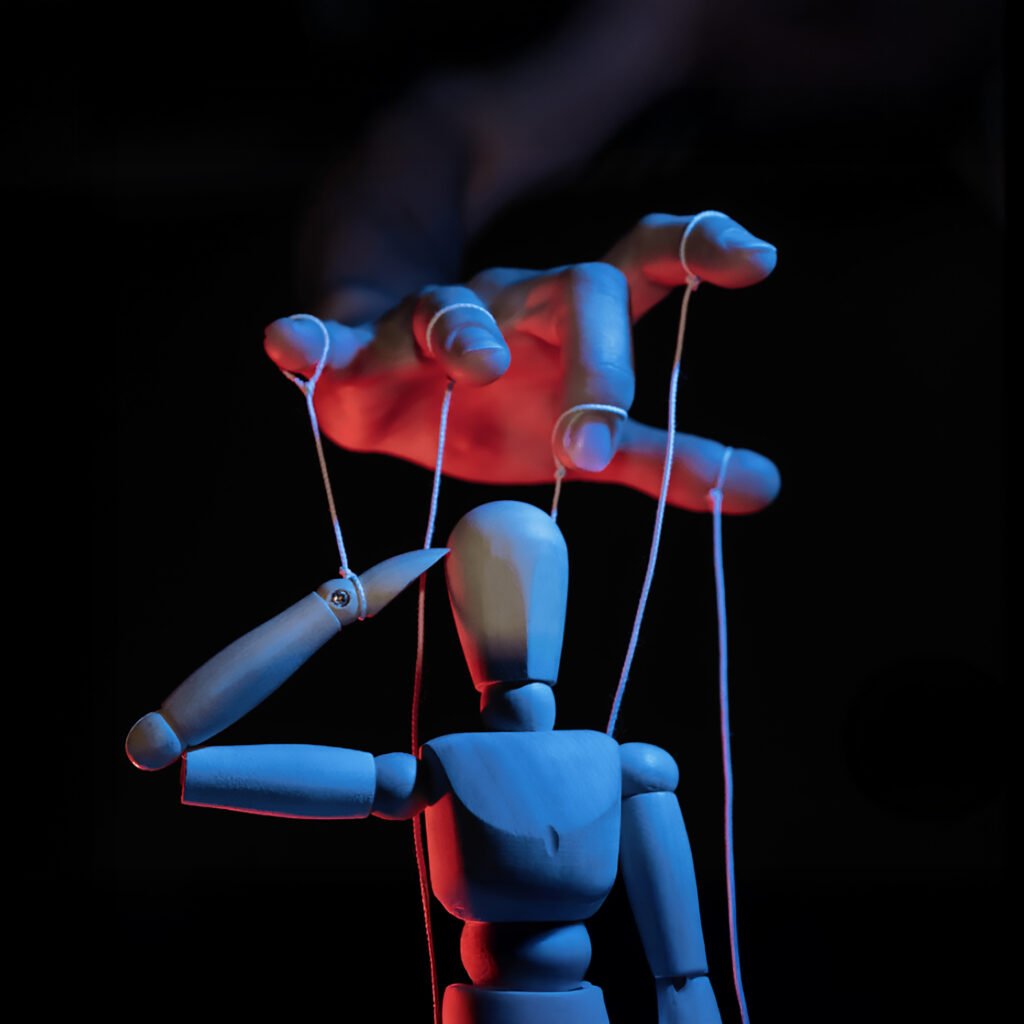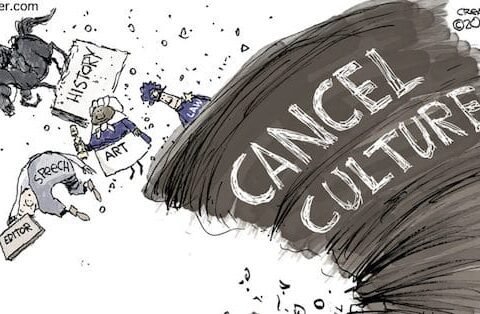Parlare di guerra significa, oggi più che mai, parlare di noi. Della nostra storia, delle nostre paure, delle trasformazioni del mondo in cui viviamo. Ho scritto questo redazionale con l’intento di restituire uno sguardo lucido e documentato su come il concetto di conflitto armato si sia evoluto nel tempo – e su ciò che ci aspetta nei prossimi anni.
Non si tratta solo di una cronaca militare o tecnologica: è un tentativo di comprendere come la guerra entri, spesso in modo subdolo, nella vita civile, nella cultura, nella politica e perfino nel nostro immaginario.
In un’epoca in cui i confini tra pace e conflitto si fanno sempre più sfumati, credo sia necessario tornare a riflettere seriamente su cosa significa combattere, subire e raccontare una guerra.
Buona lettura.
Marco Natali
Da sempre la guerra accompagna l’umanità come un’ombra fedele. Ogni epoca l’ha conosciuta, ogni civiltà l’ha praticata, ogni cultura l’ha giustificata, temuta o celebrata. E se la guerra è una costante storica, non lo è il modo in cui essa si manifesta. Le modalità del conflitto si sono evolute, riflettendo il livello tecnologico, politico e culturale delle società. Dalle battaglie campali dell’antichità agli scontri informatici del presente, ciò che chiamiamo “guerra” ha cambiato pelle, strumenti, logiche.
Dalla lancia al gladio: la guerra nel mondo antico

Nel mondo antico la guerra era un fatto diretto, fisico, riconoscibile. Non esistevano “teatri” astratti o operazioni coperte. I conflitti si combattevano sul campo, viso a viso, spesso secondo codici condivisi tra le parti. Le città-stato greche si affrontavano in battaglie formali e circoscritte. L’epica e la religione conferivano alla guerra un’aura sacrale e ineluttabile. Roma, invece, fece della guerra un mestiere, una scienza. Le sue legioni, dotate di disciplina ferrea e straordinarie capacità ingegneristiche, non solo conquistarono territori, ma imposero un modello di dominio basato sulla logistica e sull’organizzazione. Non era solo la forza bruta a decidere l’esito delle guerre, ma la capacità di pianificare, di costruire strade, di approvvigionare gli eserciti, di tenere sotto controllo i territori occupati.
E tuttavia, anche nella guerra antica, si intuisce già una verità fondamentale: il conflitto armato è sempre anche uno strumento politico, un mezzo per ridisegnare gli equilibri di potere.
Con il Medioevo, la guerra assume forme frammentate, legate alla frammentazione politica del tempo. I conflitti feudali si alternano a crociate religiose, che introducono una pericolosa novità: la giustificazione teologica della violenza. Combattere non è più solo una questione di territorio o potere, ma diventa una missione spirituale, un dovere verso Dio. Il Rinascimento e l’età moderna portano in dote la prima vera rivoluzione tecnologica della guerra: la polvere da sparo. L’archibugio e il cannone rendono obsoleti i castelli, cambiano per sempre il modo di combattere. Le guerre diventano più lunghe, più costose, più devastanti. Gli eserciti si ingrandiscono, la logistica diventa centrale.
La Guerra dei Trent’Anni, combattuta tra il 1618 e il 1648, è il prototipo della guerra moderna: una lunga spirale di alleanze, tradimenti, assedi, carestie e massacri, che coinvolge gran parte dell’Europa e prefigura l’idea di una guerra “totale”. Non più solo soldati sui campi di battaglia, ma intere popolazioni coinvolte direttamente nella distruzione.
La guerra industriale: le due guerre mondiali
Il Novecento è il secolo in cui la guerra raggiunge il suo apice di ferocia e industrializzazione. La Prima Guerra Mondiale segna la fine di un’illusione: non esistono più guerre brevi, né combattimenti cavallereschi. Le trincee, i gas, le mitragliatrici e l’artiglieria di massa annientano milioni di vite. Il fronte diventa un inferno statico, la morte assume forme meccaniche e impersonali. Ma è con la Seconda Guerra Mondiale che l’umanità tocca l’abisso. Hitler, Stalin, Roosevelt e Churchill guidano nazioni in guerra totale, dove il confine tra combattente e civile si dissolve. I bombardamenti sulle città, l’Olocausto, i campi di concentramento e infine Hiroshima e Nagasaki mostrano un volto della guerra che non ha precedenti: la capacità di annientare interi popoli.
La guerra non è più uno scontro tra eserciti, ma un’operazione sistemica che coinvolge industrie, culture, media, scienza, morale. Le scelte belliche orientano la ricerca scientifica, trasformano l’economia, modificano profondamente le società.
Guerra Fredda: conflitto senza scontro diretto

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita dell’arma atomica, il mondo entra in una nuova era. La Guerra Fredda è un conflitto pervasivo, ideologico, onnipresente, ma mai realmente esploso tra le due superpotenze principali: Stati Uniti e Unione Sovietica. È un duello di nervi, di spie, di propaganda e di proxy war – guerre per procura – combattute in Asia, Africa e America Latina.
Corea, Vietnam, Afghanistan, Angola: in questi luoghi si combattono guerre “locali” che hanno però implicazioni globali. Ogni scelta, ogni alleanza, ogni golpe militare è parte dello scacchiere mondiale. È anche la prima guerra trasmessa in diretta. Le immagini del Vietnam raggiungono i salotti americani, modificano la percezione del conflitto, alimentano le proteste. La guerra diventa uno spettacolo mediatico, un fatto culturale oltre che militare.
L’11 settembre 2001 rappresenta un punto di rottura epocale. Le Torri Gemelle in fiamme segnano l’ingresso ufficiale in un nuovo tipo di conflitto: quello contro il terrorismo globale. Al Qaeda, e poi l’ISIS, dimostrano che un’organizzazione non statale può colpire il cuore dell’Occidente, destabilizzarne le sicurezze, cambiarne le priorità. Le guerre in Afghanistan e Iraq, iniziate come reazioni “chirurgiche”, si trasformano in lunghi conflitti irregolari. Gli Stati Uniti e i loro alleati si trovano invischiati in scenari complessi, dove l’identificazione del nemico è ambigua e dove la supremazia tecnologica non garantisce la vittoria.

Nasce il concetto di guerra asimmetrica. I droni, le operazioni speciali, la sorveglianza di massa diventano parte integrante della strategia militare. I civili sono bersagli, scudi, strumenti di propaganda.
Il ritorno della guerra convenzionale: il caso Ucraina

Con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, il mondo assiste al ritorno della guerra “classica”: carri armati, missili, trincee, città assediate. Ma nulla è più come prima. La guerra si combatte anche online: le immagini diventano armi, le piattaforme sociali amplificano le emozioni, le fake news confondono la realtà.
Quello ucraino è un conflitto che unisce passato e futuro: la brutalità della guerra novecentesca si fonde con le logiche digitali del presente. Le alleanze internazionali, la pressione economica, la guerra informativa, tutto converge in un unico scenario fluido e imprevedibile. È la dimostrazione che la guerra non è mai scomparsa. Si è solo trasformata. E continua, in modi sempre nuovi, a mettere alla prova la tenuta morale, politica e civile delle nazioni.
Nel XXI secolo, i confini dei conflitti si sono dissolti. Le guerre non si combattono più soltanto nei deserti o nei centri urbani, ma anche – e sempre più spesso – nei cavi sottomarini, nei data center, nei software. È la guerra cibernetica, il nuovo fronte invisibile e permanente. Attacchi hacker a infrastrutture critiche, furti di dati sensibili, manipolazione dell’opinione pubblica, sabotaggi digitali. Queste non sono più mere ipotesi: sono eventi già accaduti. Gli attacchi al sistema elettrico ucraino, l’interferenza nelle elezioni americane del 2016, il malware Stuxnet che ha colpito le centrali nucleari iraniane: tutti episodi che mostrano come il conflitto sia entrato nel cuore dei sistemi civili.
A differenza della guerra convenzionale, il cyberwarfare sfugge a ogni regola. Non ci sono divise, né trattati condivisi, né limiti geografici. Un singolo attacco può partire da un laptop e paralizzare un Paese. È un conflitto permanente, che avviene sotto la soglia della guerra dichiarata, ma con conseguenze geopolitiche profonde. Mentre il cyberspazio è diventato il nuovo campo di battaglia digitale, lo spazio fisico è divenuto il terreno su cui si gioca la superiorità strategica tra le grandi potenze. I satelliti controllano le comunicazioni, le rotte commerciali, le coordinate dei droni, la sorveglianza globale. Chi domina l’orbita bassa, controlla il mondo. La militarizzazione dello spazio non è più una prospettiva futura: è realtà. Gli Stati Uniti hanno istituito una Space Force, la Cina ha testato armi anti-satellite, la Russia dispone di sistemi di disturbo elettromagnetico in grado di neutralizzare interi segmenti orbitali.
La posta in gioco è altissima: perdere un satellite significa perdere comunicazioni, capacità di difesa e controllo del territorio. E non esiste ancora un trattato realmente efficace che regoli l’uso militare dello spazio. Il rischio è quello di una corsa agli armamenti in orbita che può degenerare, in pochi minuti, in un conflitto incontrollabile.
Il clima come miccia dei conflitti futuri
Il cambiamento climatico non è più soltanto una minaccia ambientale. È già, e sempre più sarà, un moltiplicatore di instabilità e conflitti. L’innalzamento delle temperature, la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacci, la scarsità di risorse idriche e alimentari generano tensioni geopolitiche latenti e producono milioni di profughi ambientali.
Già oggi, in aree come il Sahel, la lotta per l’acqua e per la terra coltivabile alimenta scontri armati tra gruppi etnici. Il collasso ecologico della Siria, con la siccità che ha preceduto la guerra civile, è un caso emblematico della correlazione tra disastro ambientale e conflitto politico.
Nel prossimo futuro, il controllo delle risorse vitali – acqua, aria respirabile, terre coltivabili – potrebbe diventare il vero casus belli. I conflitti climatici non saranno dichiarati, ma saranno inesorabili, soprattutto nei territori già oggi instabili.
La guerra dell’informazione: manipolare per vincere
Mai come oggi, l’informazione è diventata un campo di battaglia. L’obiettivo non è solo vincere sul terreno, ma dominare la narrazione. Ogni guerra moderna si accompagna a una guerra delle immagini, dei frame, delle emozioni. Le piattaforme digitali sono armi di persuasione e disinformazione.
La propaganda, un tempo appannaggio degli Stati, è oggi alla portata di chiunque abbia uno smartphone e un account social. Deepfake, video manipolati, fake news, bot automatici: tutto contribuisce a costruire realtà parallele. Le opinioni pubbliche sono bersagli strategici, da orientare, confondere, mobilitare.
La guerra in Ucraina è stata, fin dai primi giorni, anche una guerra di storytelling. I tweet del presidente Zelensky, i video delle truppe russe, le foto virali, i meme: ogni contenuto è diventato parte della contesa. Il fronte dell’informazione è ovunque, e il suo esito può influenzare sanzioni, alleanze e decisioni strategiche.
Nel mondo postmoderno, lo Stato non è più l’unico attore della guerra. Le grandi aziende tecnologiche – Google, Amazon, Microsoft – controllano dati, reti, infrastrutture critiche. Alcune collaborano con eserciti, altre con governi. I confini tra interessi privati e scelte strategiche nazionali sono sempre più sfumati. Accanto a esse, si sono moltiplicati gli eserciti privati. Le “compagnie militari private” (PMC), come la russa Wagner o l’americana Blackwater, operano in zone grigie, spesso senza trasparenza e con scarso controllo giuridico. Sono attori armati che agiscono fuori dal diritto internazionale, ma con un peso crescente nelle crisi contemporanee.
Infine, l’intelligenza artificiale: il vero game-changer del futuro prossimo. Gli algoritmi sono già impiegati per analizzare immagini satellitari, prevedere movimenti nemici, guidare droni autonomi. Ma cosa accadrà quando sarà un software a decidere se attaccare o risparmiare vite umane?
Nonostante tutte le trasformazioni tecnologiche, resta una verità semplice e potente: la guerra è fatta da esseri umani, e sugli esseri umani lascia cicatrici profonde. Le conseguenze psicologiche sui militari, lo sfollamento di milioni di civili, la distruzione del patrimonio culturale e sociale: tutto questo non può essere ridotto a una questione tecnica. I conflitti armati plasmano intere generazioni. Eppure, nel cuore della guerra, emergono anche forme di resistenza, solidarietà, speranza. Dai medici volontari agli attivisti per la pace, dai cittadini che documentano gli abusi alle organizzazioni che cercano di mediare, la società civile continua a svolgere un ruolo decisivo.
La guerra non è più solo affare dei generali. È diventata una questione collettiva, etica, politica, che interroga tutti: cittadini, istituzioni, imprese, culture.
Uno scenario aperto: il futuro dei conflitti
Il futuro della guerra sarà frammentato, fluido, interconnesso. I confini tra pace e guerra si faranno sempre più labili. Ci aspettano guerre climatiche, guerre cybernetiche, guerre commerciali, guerre identitarie. Conflitti a bassa intensità ma ad alta pervasività. Una sorta di “conflitto diffuso” che si insinua in ogni piega della società globale. Ma allo stesso tempo, mai come oggi l’umanità ha strumenti per prevenire, disinnescare, evitare il conflitto armato. Il multilateralismo, il diritto internazionale, la pressione dell’opinione pubblica, la diplomazia culturale e digitale sono risorse preziose. A condizione che vengano usate.
La guerra è una scelta. Non un destino.
E il futuro dipenderà dalla volontà collettiva di imparare dal passato, di leggere il presente con lucidità, e di immaginare un domani che non abbia bisogno della violenza per risolvere i suoi nodi.
Aiutaci a far nascere il Progetto Editoriale LaLettera22, contribuisci alla raccolta fondi