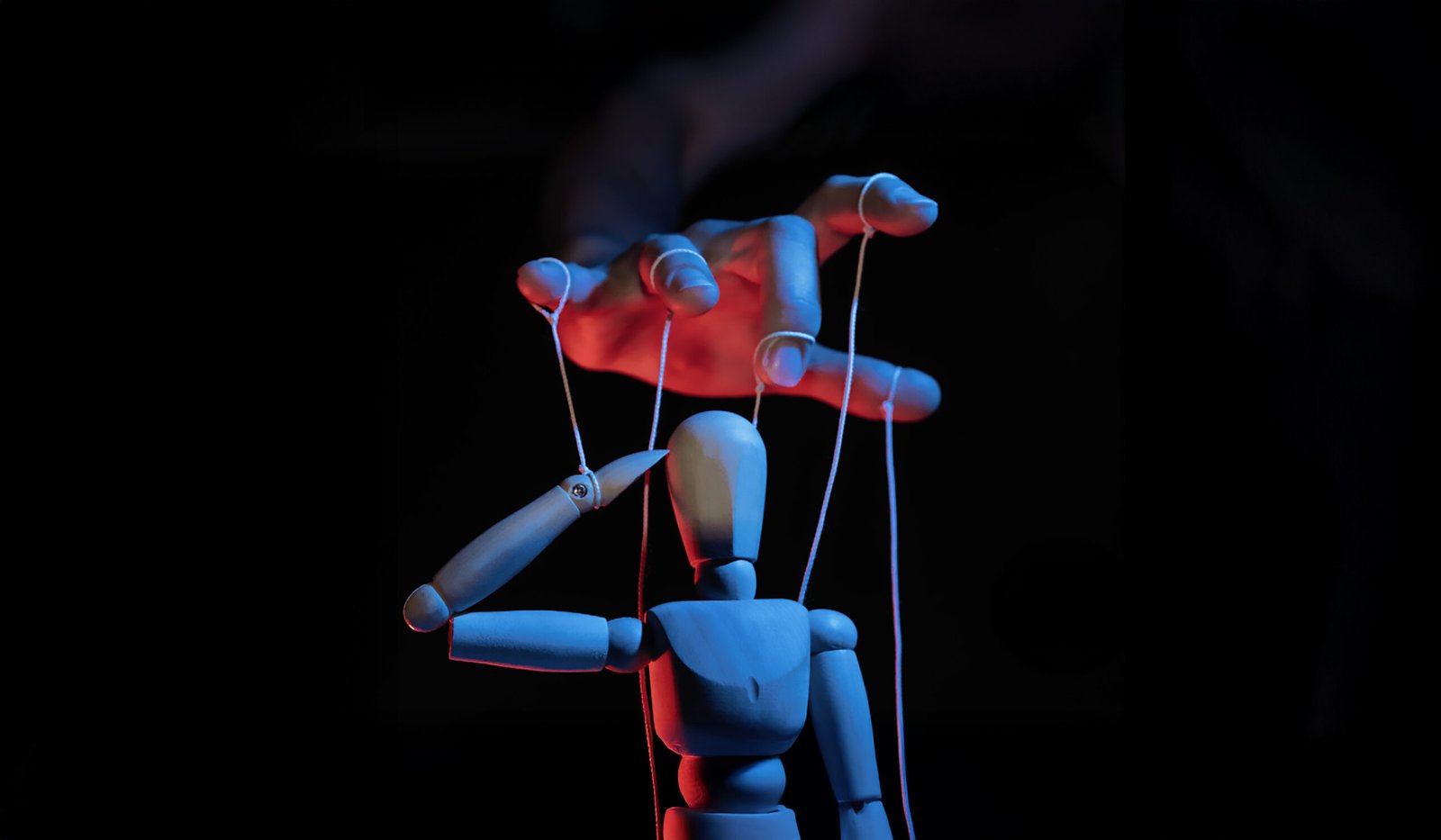Nel caos della violenza mediatica, cerchiamo ordine, comprensione e un senso di potere emotivo
Le serie violente e i documentari true crime ci affascinano perché ci danno l’illusione di controllo, giustizia e sopravvivenza emotiva.
Un brivido che ci fa sentire vivi. E invincibili
Siamo ossessionati dalla violenza. Non solo come cronaca nera o guerra trasmessa nei telegiornali, ma anche come intrattenimento: fiction criminali, thriller psicologici, survival game, documentari su serial killer, podcast con testimonianze reali di femminicidi, sparizioni o omicidi brutali.
La violenza è ovunque. E non ne abbiamo mai abbastanza.
Ma il punto è proprio questo: non siamo attratti dalla violenza in sé, ma da ci che ci permette di sperimentare. Guardare queste storie ci consente di confrontarci con il peggio che la natura umana pu offrire, senza subirlo davvero, come un esercizio di sopravvivenza emotiva.
Da “Squid Game” a Tarantino: il fascino oscuro della sofferenza mediatica
Controllare l’incontrollabile: la violenza come simulatore psicologico
Ogni volta che guardiamo una serie come Squid Game, un film disturbante o un documentario true crime, accade un piccolo paradosso psicologico: entriamo in un mondo minaccioso, crudele, imprevedibile, eppure ne siamo completamente padroni. Possiamo mettere in pausa, riavvolgere, tornare indietro. E soprattutto, possiamo prevedere il finale. Questo attiva i noi un senso di controllo molto potente.
In una realtà sempre più caotica e incerta, i contenuti violenti funzionano come una forma di “simulatore di rischio”: ci esponiamo a paure profonde, ma da una posizione di sicurezza. Viviamo la paura, ma secondo le nostre regole. E ci illudiamo, per un attimo, di poter gestire qualsiasi minaccia anche fuori dallo schermo.
Non sono i violenti ad amare la violenza
Contrariamente a un luogo comune ancora molto radicato, non sono le persone con tratti aggressivi o antisociali a essere più attratte dalla violenza mediatica. Le ricerche psicologiche dimostrano l’opposto.
Un recente studio pubblicato su Journal of Media Psychology smentisce il luogo comune che gli amanti dell’horror siano “cuori freddi”
Spesso a consumare serie crude o documentari disturbanti sono persone riflessive, empatiche, persino ansiose. Non cercano la violenza per condividerne l’impulso, ma per capirla. Per anticiparla. Per disinnescarla.
In molti casi, si tratta di spettatori con un alto livello di coscienza morale, persone che vivono la violenza come qualcosa da tenere a distanza, ma che vogliono imparare a riconoscerla e gestirla. Guardare queste storie diventa così una forma di difesa psicologica, un modo per esorcizzare paure reali attraverso la finzione o la rielaborazione del reale.
Le donne e il true crime: un esercizio di autodifesa emotiva
Uno degli aspetti più interessanti del fenomeno è che sono soprattutto le donne a guardare e ascoltare contenuti legati alla violenza reale, come documentari su femminicidi, podcast su crimini domestici, o serie incentrate su donne vittime e sopravvissute.
Questa tendenza non nasce da un gusto morboso, ma da una necessità molto più concreta e attuale di difendersi. In una società dove la violenza di genere è quotidiana e spesso invisibile, le donne cercano risposte, indizi, strategie. Osservano, analizzano, studiano. Vogliono sapere come è iniziato un abuso, cosa non è stato visto, quale dettaglio ha fatto la differenza. E lo fanno per sentirsi più pronte, più lucide, meno vulnerabili.
Inoltre, il true crime ha costruito negli anni una forte dimensione comunitaria. Esistono forum, newsletter, club digitali, gruppi online e podcast condotti da donne per altre donne. Luoghi dove condividere non solo la passione per il genere, ma anche paure e esperienze personali. È un modo per trasformare il trauma in conoscenza, e la vulnerabilità in consapevolezza.
Il bisogno di giustizia e la ricompensa morale
Molti dei contenuti violenti, soprattutto nelle serie TV, si concludono con la punizione del colpevole, la cattura dell’assassino, la vendetta della vittima o il trionfo della giustizia. Questo schema narrativo, per quanto semplificato, soddisfa un bisogno morale profondo: vedere che il male ha un prezzo.
Nella vita reale, spesso le cose non finiscono così. I colpevoli restano impuniti, la giustizia è lenta e il dolore delle vittime si disperde nel silenzio. Ma sullo schermo, l’ordine viene ripristinato. Il male ha un volto, un nome, una pena. Arriva un lieto fine. E questo ci consola.
Viviamo in tempi violenti. E abbiamo bisogno di comprenderli
C’è per un aspetto fondamentale e determinante da considerare: il successo di questi contenuti è figlio del tempo in cui viviamo.
La nostra epoca è segnata da una forma di violenza diffusa e trasversale. Non solo quella fisica, che purtroppo riempie ancora le cronache quotidiane, ma anche quella economica, simbolica, subdola e sociale. Siamo bombardati da conflitti, crisi ambientali, guerre, collassi istituzionali. Ma anche da microviolenze quotidiane: precarietà, isolamento, disinformazione, burnout e aggressività digitale. Tutto questo alimenta una percezione costante di minaccia, a cui cerchiamo risposte.
I contenuti violenti che consumiamo non sono un sintomo di barbarie culturale. Sono, piuttosto, uno specchio e una cura. Ci aiutano a riconoscere la violenza, darle un nome, raccontarla, e a restituirle un senso, per quanto possibile. E forse, nel farlo, riusciamo anche a riconquistare un po’ di quella sicurezza interiore che il mondo ci ha tolto.
La violenza non ci attrae. Ci protegge.
Guardare serie disturbanti o ascoltare storie di crimini non ci rende più cinici, ma più consapevoli. Cerchiamo la violenza per non subirla. La osserviamo per imparare a riconoscerla. La analizziamo per non esserne annientati.
E se restiamo incollati allo schermo fino alla punizione del colpevole, non è perché ci piace soffrire o siamo dei sadici, ma perché in quel finale vediamo un mondo che si rimette in ordine. Anche se solo attraverso lo schermo.