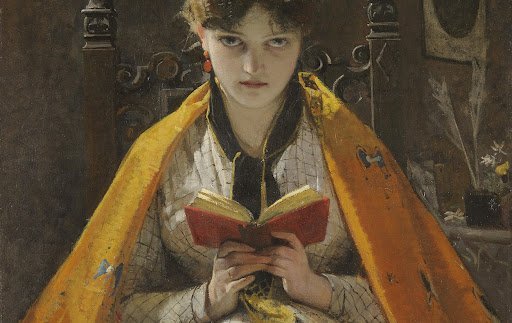Nel XXI secolo, la lettura ha perso quella centralità che aveva avuto nei secoli passati. Se un tempo il libro era il principale strumento di conoscenza, evasione e riflessione, oggi deve contendersi l’attenzione con un’infinità di altri stimoli. Serie TV, podcast, social media, contenuti brevi e visivi: viviamo immersi in un flusso continuo di notifiche e informazioni che frammentano la nostra concentrazione.
Eppure, in mezzo a questo rumore, l’atto di leggere continua a rappresentare qualcosa di diverso. Un gesto intimo, un tempo lento, un’occasione per esercitare la mente in modo profondo. Ma quanti lo compiono ancora con regolarità? I dati suggeriscono che la lettura, pur conservando il suo valore, sta perdendo terreno nella vita quotidiana di molte persone.
I numeri che raccontano una crisi
Secondo l’ISTAT, nel 2023 soltanto il 40,1% degli italiani sopra i sei anni ha letto almeno un libro nei dodici mesi precedenti, escludendo testi scolastici o professionali. Una percentuale ben lontana dal 46,8% registrato nel 2010. Un calo che, purtroppo, non riguarda solo i lettori occasionali: anche la categoria dei cosiddetti “lettori forti” – cioè coloro che leggono almeno un libro al mese – è scesa al 6,4%.
Il fenomeno non è limitato all’Italia. Negli Stati Uniti, una delle società più mediatizzate e digitalizzate al mondo, un’indagine del Pew Research Center condotta nel 2021 ha rilevato che circa il 23% degli adulti non ha letto neanche una parte di un libro nell’anno precedente. Nessun romanzo, nessun saggio, nemmeno un audiolibro. Un dato impressionante, soprattutto se confrontato con le risorse disponibili e l’accessibilità dei contenuti. Questa crisi di lettura riguarda tutte le fasce d’età e tutti i livelli sociali, con variazioni regionali, culturali ed economiche. Colpisce di più chi ha un titolo di studio basso, chi vive in aree meno urbanizzate, chi ha redditi inferiori. Ma non risparmia nemmeno chi ha più strumenti a disposizione.
Il tempo per leggere sembra ridursi per tutti.
Gli e-book non bastano
Negli ultimi dieci anni, si è parlato molto della possibilità che la tecnologia potesse salvare la lettura. E-book, audiolibri, app, piattaforme digitali: i libri sono diventati più accessibili che mai. Oggi bastano pochi secondi per scaricare un’intera biblioteca sul proprio smartphone. Ma la disponibilità di contenuti non coincide automaticamente con il loro consumo.
In Italia, ad esempio, il tasso di lettura è rimasto stabile o leggermente in calo, nonostante la crescita del mercato digitale. Nel 2022, solo il 39,3% della popolazione ha letto almeno un libro in un anno. E nel 2023, nonostante una piccola ripresa, non si è tornati ai livelli pre-pandemia. È chiaro che la tecnologia può essere uno strumento utile, ma non è sufficiente. L’accessibilità non risolve il problema culturale. Se la lettura non viene percepita come un valore, un piacere, un’abitudine da coltivare, neanche il dispositivo più avanzato potrà sostituire il desiderio di aprire un libro e perdersi tra le sue pagine.
I giovani leggono davvero?
Un dato sorprendente riguarda i giovanissimi: nella fascia tra gli 11 e i 14 anni, oltre il 57% ha letto almeno un libro nel 2022. Le ragazze, in particolare, superano il 60%, confermando una tendenza storica che vede il pubblico femminile più incline alla lettura. Tuttavia, questo interesse precoce non si mantiene nel tempo. Tra i 20 e i 24 anni, la percentuale scende al 40,5%. E man mano che si entra nella vita adulta – con l’università, il lavoro, gli impegni familiari – il tempo e la motivazione per leggere sembrano svanire.
Ma il problema non è solo quantitativo. I test PISA dell’OCSE, che valutano le competenze degli studenti quindicenni, mostrano una preoccupante difficoltà nella comprensione del testo. Circa un quarto degli adolescenti italiani non raggiunge il livello minimo per interpretare in modo corretto ciò che legge. Una difficoltà che non si limita alla scuola, ma ha conseguenze molto più ampie: riguarda la capacità di comprendere un contratto, un’informazione sanitaria, un articolo di giornale.
In altre parole, riguarda la cittadinanza attiva.
Giornali chiusi, articoli letti a metà
La crisi della lettura coinvolge anche l’informazione. I giornali vendono sempre meno copie, le edicole chiudono, e anche le riviste di settore faticano a sopravvivere. Sul web, dove le notizie sono gratuite e accessibili, i lettori spesso si limitano ai titoli o alle prime righe. Non esistono dati ufficiali su quanti leggano un articolo fino in fondo, ma molte redazioni online utilizzano metriche che mostrano come la permanenza media su una pagina sia di pochi secondi. In un contesto in cui le notizie si consumano come snack, la profondità perde terreno. L’approfondimento diventa un lusso, e con esso cresce il rischio di fraintendimenti, fake news e polarizzazione.
C’è ancora chi legge per piacere?
La risposta è sì. Molti italiani continuano a leggere per passione, per curiosità, per evasione. Il piacere della lettura, per chi lo conosce, resta intatto. Ma i numeri ci dicono che si tratta di una minoranza: solo il 16,3% dei lettori può essere definito “forte”, cioè legge regolarmente almeno un libro al mese. Le biblioteche cercano di rispondere a questa crisi ampliando l’offerta: non solo libri cartacei, ma anche prestiti digitali, e-book, audiolibri. Alcune strutture organizzano incontri, club del libro, laboratori per bambini. Iniziative lodevoli, che però spesso si scontrano con mancanza di fondi, carenza di personale, disinteresse istituzionale.
Il futuro della lettura? Dipende da noi
Cosa possiamo fare per invertire la rotta? La prima risposta è: iniziare da piccoli. I dati dimostrano che chi cresce in un ambiente ricco di libri, in cui si legge ad alta voce fin dall’infanzia, ha più probabilità di diventare un lettore da adulto. Ma non basta delegare tutto alle famiglie. Servono politiche pubbliche serie e continuative. Servono scuole dove la lettura non sia solo un compito da svolgere, ma una parte viva dell’esperienza educativa. Servono biblioteche scolastiche attive, progetti di educazione alla lettura, investimenti nella formazione degli insegnanti.
Anche il mondo del lavoro può fare la sua parte. Alcune aziende promuovono la lettura tra i dipendenti, organizzano gruppi di lettura aziendali, offrono spazi di scambio culturale. Sono iniziative ancora rare, ma che mostrano quanto la lettura possa essere un elemento di crescita personale e collettiva.
Infine, tocca a noi. A ciascuno di noi. Leggere, consigliare, regalare libri. Parlare di ciò che leggiamo. Condividere articoli, romanzi, idee. Perché leggere non è solo un passatempo: è uno strumento per comprendere il mondo, immaginarne uno