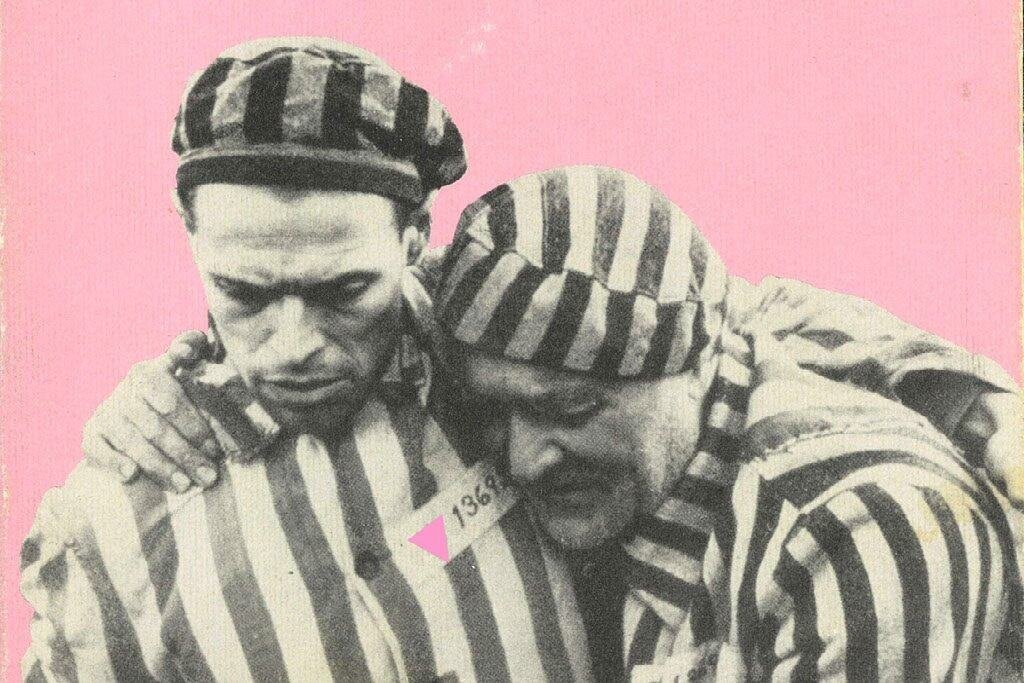L’intesa sui dazi firmata tra Stati Uniti e Unione Europea il 27 luglio 2025 ha segnato una svolta importante nei rapporti commerciali transatlantici. Mentre Donald Trump celebra un successo strategico e politico, l’Unione Europea si ritrova a dover digerire condizioni chiaramente squilibrate. Il compromesso raggiunto a Turnberry, in Scozia, tra il presidente statunitense e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è stato presentato come una soluzione per evitare una guerra commerciale totale, ma nei fatti ha consolidato un vantaggio netto per Washington.
Le condizioni dell’accordo
Il punto chiave dell’accordo è l’imposizione di dazi del 15% su gran parte delle importazioni europee negli Stati Uniti. Una misura che tocca settori cruciali come automobili, semiconduttori e persino prodotti farmaceutici. Nonostante gli sforzi dell’Unione, restano in vigore anche dazi al 50% sull’acciaio e sull’alluminio, anche se verrà introdotto un sistema di quote progressive ancora da definire.
Al contrario, l’Unione Europea non applicherà alcun dazio sulle importazioni statunitensi, una concessione rilevante considerando che gli USA rappresentano il primo partner commerciale del blocco europeo.
Oltre a ciò, Bruxelles si è impegnata ad acquistare beni energetici dagli USA per un valore di 750 miliardi di dollari(circa 639 miliardi di euro) e a investire nel mercato statunitense altri 600 miliardi di dollari. Un impegno complessivo di oltre 1.300 miliardi che solleva interrogativi su come e quando verrà effettivamente attuato.
Una vittoria politica per Trump
Donald Trump, in piena campagna per consolidare la sua immagine da negoziatore duro e vincente, ha potuto presentare questo accordo come la prova che le sue tattiche di pressione funzionano. Aveva promesso “90 accordi in 90 giorni” e finora ne aveva siglati meno di dieci, per lo più con paesi asiatici. Ottenere un’intesa con l’UE, anche se a condizioni fortemente sbilanciate, rappresenta una grande vetrina.
Il livello dei dazi, per quanto elevato, è stato accolto con sollievo dai leader europei solo perché inferiore alle minacce precedenti: Trump aveva minacciato dazi fino al 50% su tutti i prodotti europei, poi ridotti al 30%, infine abbassati al 15%. Una strategia di massima pressione che ha prodotto risultati concreti.
Un accordo asimmetrico e criticato
Molti osservatori, tra cui il Financial Times, hanno sottolineato come questo patto sia fortemente sbilanciato a favore degli Stati Uniti. L’UE ha rinunciato a misure difensive efficaci, accontentandosi di evitare il disastro.
Le concessioni europee non si fermano ai dazi: l’intesa segue altri compromessi già accettati nei mesi scorsi, tra cui l’aumento delle spese militari NATO al 5% del PIL per ogni paese membro, e l’esenzione delle multinazionali statunitensi dalla nuova tassa globale sulle grandi aziende.
Inoltre, gli impegni energetici e militari presi da Bruxelles sembrano andare in direzione opposta rispetto agli obiettivi climatici e strategici dell’Unione. La dipendenza da gas e petrolio statunitense, unita all’acquisto di armamenti, rischia di allontanare l’UE dalle sue stesse linee guida di autonomia e sostenibilità.
Le divisioni interne europee
Uno dei principali limiti dell’azione dell’UE è stata la mancanza di coesione tra i 27 Stati membri. Paesi come Franciaspingevano per una linea più dura contro Trump, mentre Germania e Italia temevano le ripercussioni economiche di uno scontro diretto. Berlino, in particolare, è stata cauta data la forte esposizione dell’industria automobilistica tedesca al mercato statunitense.
L’Italia, dal canto suo, ha mantenuto un profilo basso. Il governo di Giorgia Meloni ha cercato di sfruttare i buoni rapporti personali con Trump, ma senza ottenere risultati significativi sul piano delle trattative.
L’ombra della Cina
Il confronto con la Cina offre un termine di paragone interessante. Contro Pechino, Trump ha mantenuto una linea durissima, arrivando a imporre dazi del 145% e interrompendo di fatto gran parte del commercio bilaterale. Ma la Cina, invece di cedere, ha adottato una strategia di resistenza, accettando le conseguenze pur di non piegarsi.
L’Europa ha scelto una strada diversa: negoziare e cedere per contenere i danni immediati, ma a costo di perdere margini di manovra a lungo termine.
I numeri e le incognite
Le cifre promesse – 750 miliardi di dollari in acquisti energetici e 600 miliardi in investimenti – sono imponenti, ma restano prive di dettagli concreti. Senza una roadmap chiara, si rischia che rimangano promesse politiche più che impegni vincolanti.
Lo stesso vale per la gestione delle quote su acciaio e alluminio: al momento manca trasparenza, e i settori industriali coinvolti attendono indicazioni precise.
L’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea può essere letto in due modi: come un compromesso necessario per evitare danni peggiori o come una resa politica ed economica di fronte alle pressioni americane. Per Trump è un trofeo elettorale, per l’UE un risultato che solleva più domande che certezze.