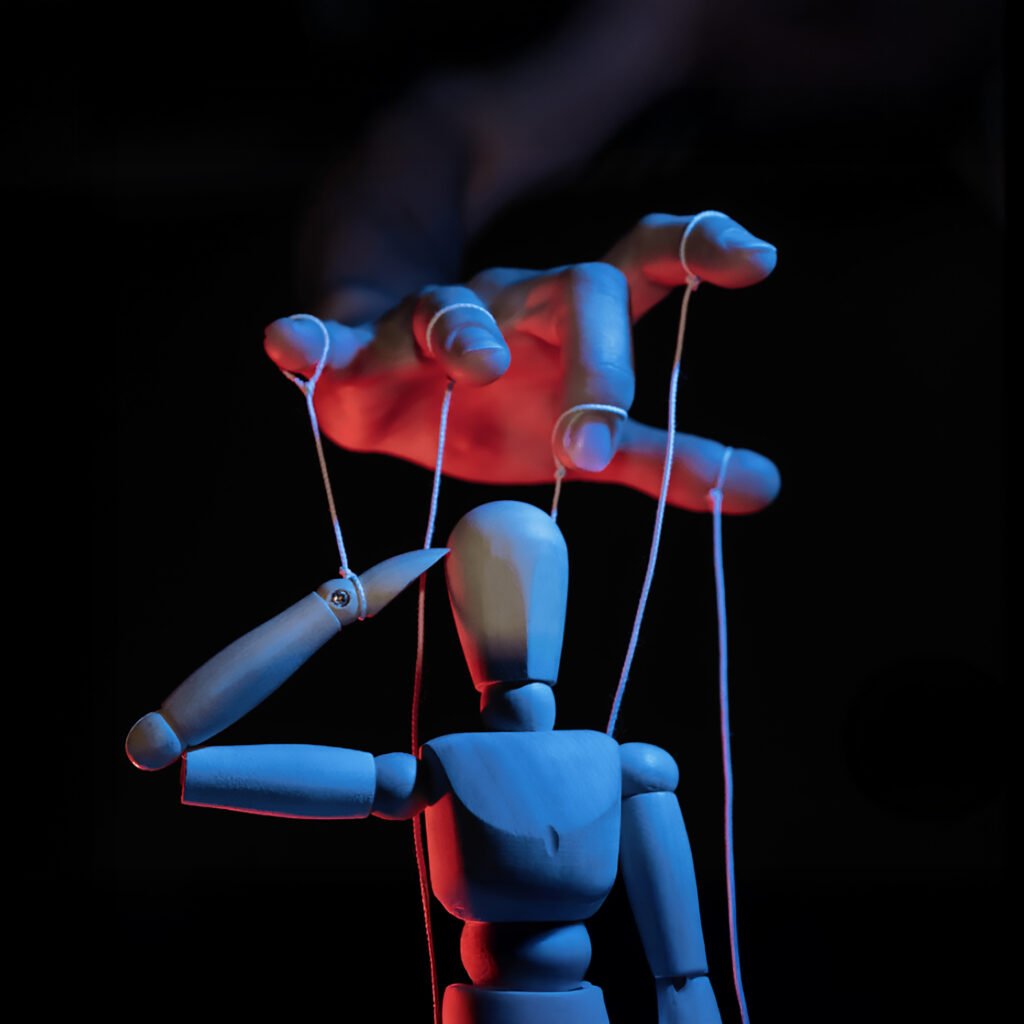6 marzo 1951, tribunale federale di Foley Square a New York. Julius ed Ethel Rosenberg siedono sul banco degli imputati. Di fronte a loro, il giudice federale Irving R. Kaufman.
L’accusa è di aver passato segreti atomici all’Unione Sovietica. Due anni dopo, Julius ed Ethel moriranno sulla sedia elettrica. Saranno i primi e unici civili statunitensi giustiziati per spionaggio in tempo di pace.
La fine del monopolio nucleare americano
Alla fine della Seconda guerra mondiale, Stati Uniti e Unione Sovietica sono alleati contro il nemico comune: la Germania nazista. Ma i costi umani del conflitto sono drammaticamente diversi. Gli Stati Uniti hanno perso 38.448 soldati. L’Unione Sovietica, invece, oltre 8 milioni di militari e 20 milioni di civili.
Con il successo del Progetto Manhattan, culminato con il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, Washington crede di avere un vantaggio strategico incolmabile. Si pensa che ai sovietici servano almeno dieci anni per sviluppare un’arma nucleare. Nemmeno Truman sospetta nulla quando, durante l’incontro con Churchill e Stalin alla Conferenza di Potsdam, nel luglio 1945, informa quest’ultimo che gli Stati Uniti sono in possesso della bomba atomica. Stalin, per nulla sorpreso, si limita a rispondere freddamente: “Spero che il tuo paese ne faccia buon uso.”
E invece, nel 1949, un chimico americano, durante analisi di routine sulle acque del Kazakistan, trova tracce di uranio alterato: una firma inequivocabile di un’esplosione atomica. I sovietici hanno testato la loro prima bomba nucleare, una copia quasi identica di “Fat Man”, l’ordigno americano sganciato su Nagasaki. Gli Stati Uniti non sono più l’unica potenza con l’arma più pericolosa del mondo.
Quando il nemico è in casa: la caccia al comunista
La paura del comunismo non nasce con la scoperta della bomba sovietica. Già negli anni ’20, dopo la Rivoluzione d’Ottobre, negli Stati Uniti si diffonde un’ondata di panico anticomunista nota come “Red Scare”. Scioperi operai e attentati anarchici alimentano la convinzione che il bolscevismo possa attecchire anche in America.
Durante la Seconda guerra mondiale, USA e URSS si trovano alleati contro Hitler, ma si tratta di una fiducia di facciata: sotto la cooperazione resta viva una diffidenza ideologica mai sopita.
Nel dopoguerra, quella diffidenza si trasforma in ostilità aperta. L’Europa è divisa in due, con i paesi dell’Est sotto l’influenza sovietica e quelli dell’Ovest sotto quella americana. Churchill parla di “Cortina di ferro” per descrivere il nuovo confine invisibile che spacca il continente e con esso, il mondo.
È la Guerra Fredda: una lunga sfida politica, militare e culturale, combattuta a colpi di propaganda, minacce atomiche e sospetti incrociati.
Negli Stati Uniti, la minaccia comunista diventa anche interna. Si parla di maccartismo, dal nome del senatore Joseph McCarthy, che lancia una campagna contro i presunti sovversivi nascosti nel cuore della società americana. Nascono liste nere, interrogatori, udienze pubbliche: basta un’accusa, anche infondata, per perdere il lavoro o la reputazione.
La Commissione per le attività antiamericane colpisce anche il mondo del cinema: Walt Disney testimonia contro i sindacati, Charlie Chaplin viene sospettato di simpatie comuniste. La democrazia americana, nel tentativo di difendersi, finisce per auto-sospettarsi, alimentando una vera e propria psicosi nazionale.
La catena che porta ai Rosenberg
In questo clima di sospetti e paure, un programma segreto americano, dal nome in codice Venona, inizia a decifrare i messaggi cifrati dell’intelligence sovietica. Più messaggi vengono decifrati, più emerge che per i sovietici l’atomica non è mai stata una novità: già negli anni ’40, spie sovietiche operano all’interno dello stesso Progetto Manhattan.
Inizia così una reazione a catena di accuse e tradimenti. Il primo a essere scoperto è Klaus Fuchs, uno scienziato arrestato nel 1950 in Inghilterra. Con la sua confessione, salta fuori il nome di un altro anello della catena: l’americano Harry Gold, che a sua volta fa il nome di un tecnico di laboratorio, David Greenglass. E poi il cerchio si chiude. Greenglass parla di un “contatto di famiglia” che avrebbe gestito documenti top secret: suo cognato Julius. E parla anche della donna che, secondo lui, avrebbe trascritto quei documenti: sua sorella, Ethel.
Ed è così che, nel luglio 1950, Julius Rosenberg viene arrestato, seguito poche settimane dopo da sua moglie, Ethel.
Ma chi sono davvero i Rosenberg? Sono effettivamente così pericolosi come sostiene l’accusa?
Chi erano i Rosenberg
Julius ed Ethel Rosenberg sono due americani di origine ebrea. Lui, comunista fin da giovane, ha studiato ingegneria. Lei, dotata di una bella voce, abbandona il sogno di fare la cantante per lavorare come dattilografa. È lì che si avvicina alla lotta operaia, ed è lì che conosce Julius. Si sposano nel 1939.Quando vengono arrestati, lasciano due figli, di tre e sette anni.
Le loro foto sono ovunque: Julius, con i suoi occhiali tondi e l’aria timida; Ethel, con lineamenti delicati e uno sguardo serio. Durante tutto il processo, nessuno dei due pronuncia una sola parola in propria difesa. Scelgono il silenzio, rifiutando di collaborare con le autorità o di denunciare altri nomi.
Il loro processo e la condanna a morte dividono profondamente l’opinione pubblica americana e internazionale. Molti intellettuali si espongono per difenderli: Bertolt Brecht, Dashiell Hammett, Frida Kahlo e suo marito Diego Rivera, Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso.
Papa Pio XII chiede pubblicamente che venga risparmiata loro la pena di morte.
19 giugno 1953: la sedia elettrica
Dopo numerosi appelli respinti, il 19 giugno 1953, Julius ed Ethel Rosenberg vengono giustiziati nel carcere di massima sicurezza di Sing Sing. Lì è presente una sola sedia elettrica: la chiamano “Old Sparky”, e si trova in fondo al corridoio noto come “Last Mile”.
Da quando sono stati arrestati, Julius ed Ethel non si sono più visti. A loro non è concesso nemmeno un ultimo addio: le esecuzioni avvengono separatamente, a poca distanza l’una dall’altra, in presenza di pochissimi testimoni. Quando muoiono, hanno rispettivamente 35 e 37 anni. All’ esterno del carcere si radunano centinaia di manifestanti. C’è chi prega, c’è chi grida allo scandalo. La loro morte diventa un simbolo tragico della Guerra Fredda: un atto definitivo compiuto in un’epoca in cui il dubbio è diventato pericoloso quanto la colpa.
Colpevoli, ma fino a che punto?
Decenni dopo l’esecuzione, con la desecretazione dei documenti del Progetto Venona e l’apertura di alcuni archivi sovietici, emerge che Julius Rosenberg ha effettivamente collaborato con l’intelligence di Mosca.
Ma i segreti militari che ha trasmesso non riguardano la bomba atomica.
Ethel, con ogni probabilità, non ha avuto un ruolo operativo: forse sapeva, forse ha taciuto per proteggere il marito, gli amici, o i suoi ideali comunisti.
E allora perché una pena così sproporzionata?
Perché in quel momento, agli Stati Uniti serve un esempio. E i Rosenberg sono un capro espiatorio perfetto. Non hanno mai nascosto le loro simpatie comuniste. Sono stati incastrati da un ex compagno, David Greenglass, che ha scelto di mandare la sorella sulla sedia elettrica pur di salvarsi. Per incarcerarli non serve nemmeno tirare in ballo il Progetto Venona, che il governo vuole tenere segreto.
La loro morte deve far paura. Deve servire da monito a chiunque abbia idee “antiamericane’’. Del resto, non è la giustizia ciò che spesso muove la macchina americana, ma la paura.
I bolscevichi, i comunisti, i “nemici della libertà”: gli Stati Uniti hanno sempre avuto bisogno di un volto da additare, di qualcuno da bruciare per tenere in piedi il loro mito. Il caso Rosenberg non è solo un processo. È una messa in scena.
La prova che la nazione che si proclama paladina della libertà non esita a sacrificare chi serve, pur di sentirsi al sicuro.