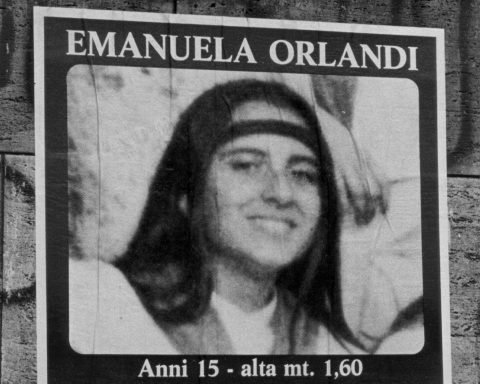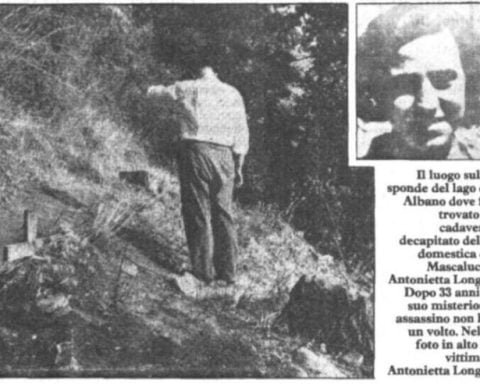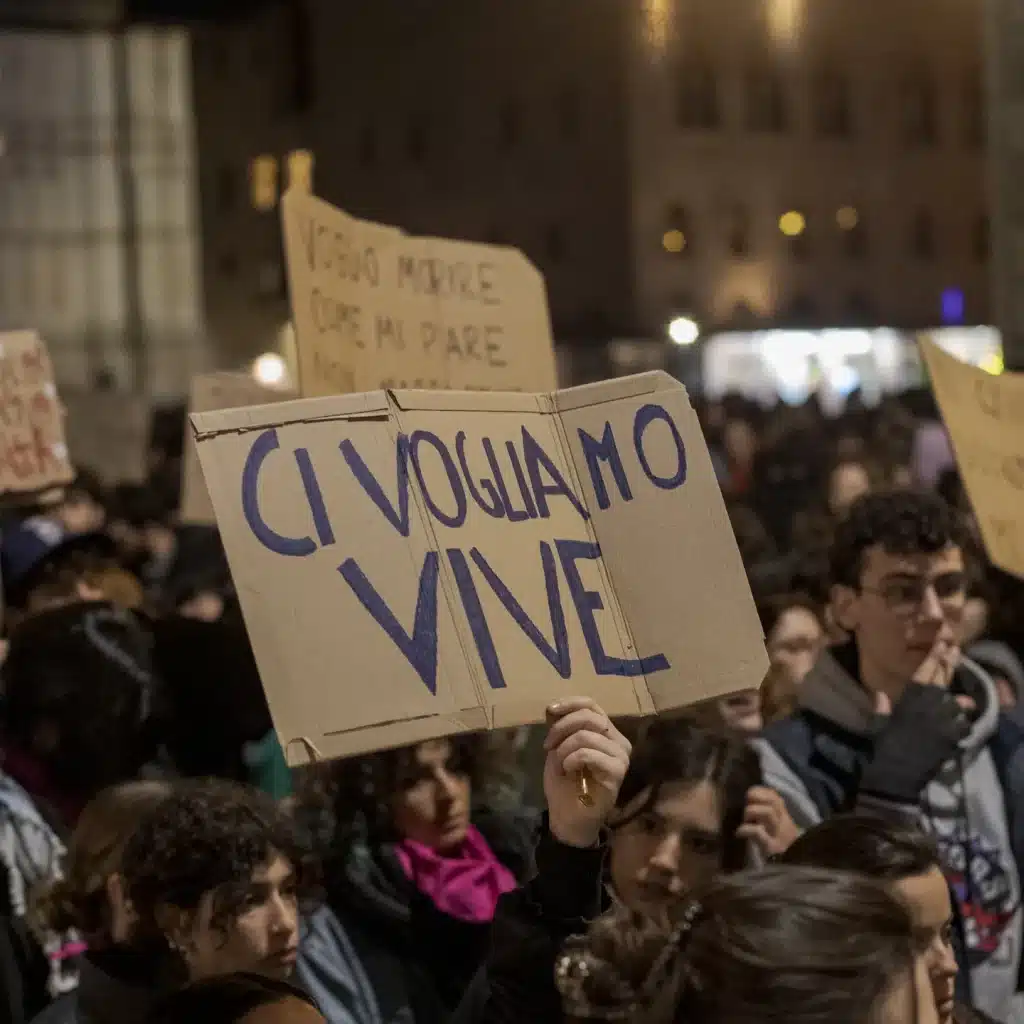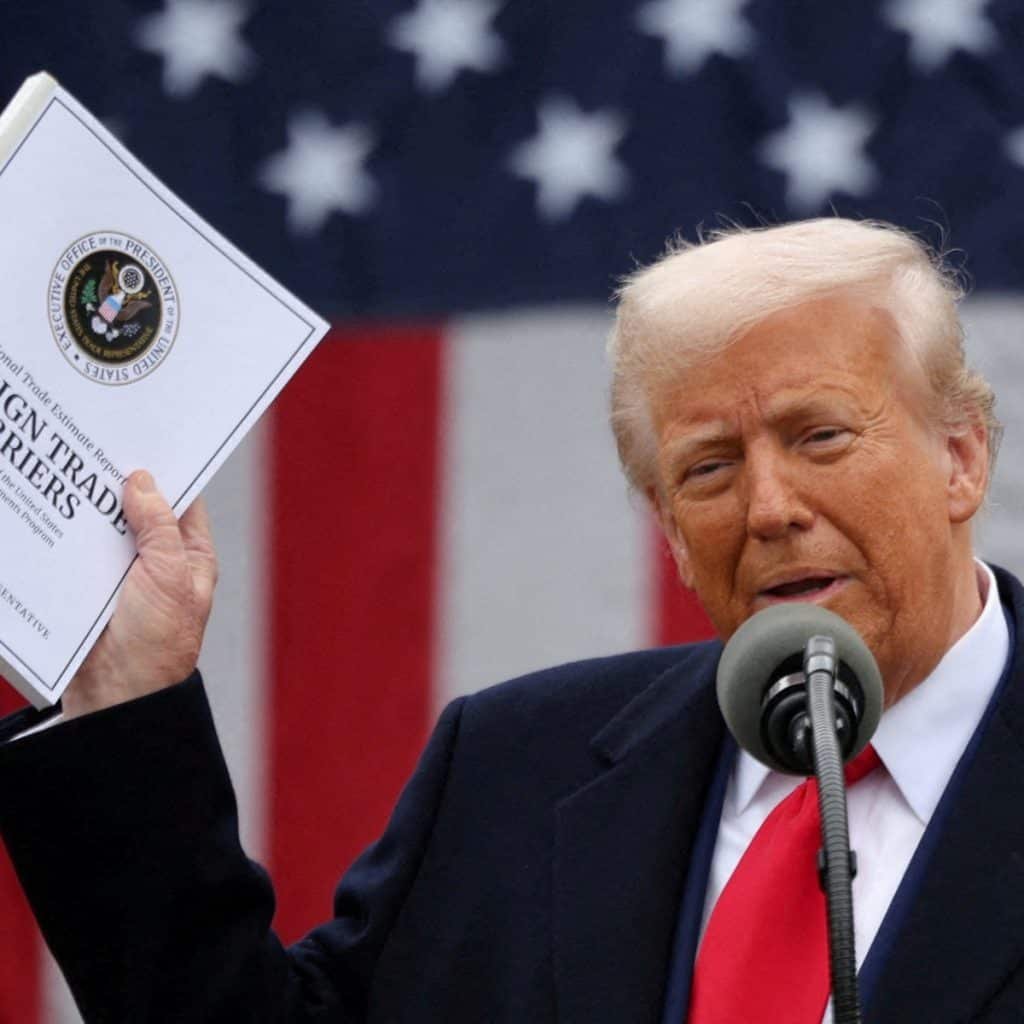Roma, 21 marzo 1979. Una Citroën Ami 8, parcheggiata male in via Orazio, attira l’attenzione di alcuni passanti. Dentro, al posto di guida, c’è un uomo accasciato sul volante. È morto. Quattro colpi di pistola, uno alla gola. L’auto è in disordine, ma il corpo sembra composto. Non è una rapina. È un’esecuzione. L’uomo si chiamava Carmine “Mino” Pecorelli. Aveva 51 anni. E stava scavando troppo a fondo.
La sua morte, archiviata ufficialmente come un omicidio irrisolto, è ancora oggi avvolta nel mistero. Un mistero fatto di potere, segreti di Stato, rapporti oscuri tra politica, mafia e servizi segreti. E soprattutto: di verità non dette.
Chi era Mino Pecorelli?
Mino Pecorelli non era un giornalista qualsiasi. Nato a Sessano del Molise nel 1928, era cresciuto in una famiglia modesta e si era laureato in giurisprudenza. Aveva iniziato la carriera come assistente parlamentare, diventando presto un esperto delle dinamiche del potere romano. Aveva anche avuto contatti con il SIFAR, il servizio segreto militare dell’epoca, e si vociferava che avesse una fitta rete di relazioni con ambienti dell’intelligence.
Poi, il salto nel giornalismo. Pecorelli fondò prima Il punto, poi nel 1975 Osservatore Politico, conosciuto da tutti come OP. Ma OP non era un semplice settimanale politico. Era un ibrido tra giornalismo investigativo e intelligence. Le sue pagine pubblicavano dossier riservati, nomi, trame, accuse mai viste altrove. Pecorelli sembrava sapere sempre qualcosa in più. E questo qualcosa lo rendeva, inevitabilmente, scomodo.
OP era letto da politici, magistrati, uomini dei servizi, industriali. Nessuno poteva ignorarlo. Nessuno poteva prevedere cosa avrebbe pubblicato. Ma soprattutto: nessuno capiva da dove arrivassero le sue informazioni. Alcuni lo accusarono di ricatto, di essere più vicino a Gladio che alla stampa libera. Altri lo consideravano una spina nel fianco del sistema, una mina vagante in un’Italia sempre più in bilico tra democrazia e autoritarismo.
Le lettere di Aldo Moro
La fine di Mino Pecorelli inizia a scriversi durante i 55 giorni più drammatici della storia italiana: il rapimento di Aldo Moro, nel 1978. Mentre il presidente della Democrazia Cristiana era prigioniero delle Brigate Rosse, scriveva lettere dal cosiddetto “carcere del popolo”. Lettere durissime, piene di accuse verso i suoi colleghi di partito, colpevoli – secondo lui – di averlo abbandonato. Alcune di queste lettere furono rese pubbliche. Ma altre, più scottanti, vennero presumibilmente censurate.
Pecorelli le ottiene. O almeno, dice di averle. E comincia a pubblicarne alcune, a tratti, con allusioni e anticipazioni. In un numero di OP, scrive che “se uscissero tutte le lettere, una carriera eccellente finirebbe bruscamente”. Il riferimento è chiaro: Giulio Andreotti. L’uomo più potente d’Italia in quel momento.
Ma non c’erano solo le lettere. Pecorelli, in quegli anni, aveva messo mano a dossier su Licio Gelli, sulla loggia P2, sul golpe Borghese, sui finanziamenti occulti della CIA, sul caso Lockheed. Aveva parlato – tra i primi – del legame tra la mafia siciliana e i palazzi romani. Aveva scritto di un “Stato parallelo”, molto prima che diventasse un tema da talk show.
L’ultima inchiesta di Pecorelli, pubblicata pochi giorni prima di morire, è intitolata “La polvere si alza”. Un riferimento ai movimenti sotterranei dentro lo Stato. Ma anche, forse, al fatto che qualcosa stava per accadere. E infatti accadde.
La sera del 21 marzo 1979, Mino Pecorelli viene ucciso in modo chirurgico. Un colpo alla gola. Tre al petto. L’arma: una pistola calibro 7.65. I proiettili? Marca Gevelot, in dotazione alle strutture della NATO. E in particolare… a Gladio, l’organizzazione paramilitare segreta nata per contrastare un’eventuale invasione sovietica, ma coinvolta in numerosi misteri italiani.
Gli inquirenti trovano l’auto ancora chiusa a chiave. Nessun segno di colluttazione. Chi l’ha ucciso, lo conosceva. Forse è salito in macchina con lui. Forse è stato proprio lui ad aprire la portiera.
Già questo basterebbe a far tremare i polsi. Ma il colpo di scena arriva vent’anni dopo.
Il processo a Giulio Andreotti
Nel 1999, Giulio Andreotti – ex presidente del Consiglio, sette volte premier, uomo chiave della Prima Repubblica – viene rinviato a giudizio come mandante dell’omicidio. Insieme a lui: il generale dei carabinieri Giovanni Musumeci, il boss mafioso Pippo Calò, e Massimo Carminati, neofascista legato alla banda della Magliana e al terrorismo nero.
L’accusa è durissima: Pecorelli sarebbe stato eliminato per ordine di Andreotti, che temeva la pubblicazione delle lettere di Moro e altri documenti compromettenti. Secondo i giudici, Pecorelli stava per “colpire al cuore” la carriera del senatore. Il processo è uno shock per l’opinione pubblica. Mai prima di allora un ex capo di governo era stato accusato di essere il mandante di un omicidio.
Nel 2002, la Corte d’Appello condanna Andreotti all’ergastolo. Ma due anni dopo, la Cassazione lo assolve per insufficienza di prove. Il reato c’è, ma le prove non bastano. Andreotti esce assolto. Ma la macchia resta.
Un archivio scomparso
Tra le tante ombre del caso Pecorelli, ce n’è una che ancora inquieta: il suo archivio personale. Si diceva che contenesse documenti esplosivi: rapporti su logge massoniche deviate, legami tra mafia e politica, carte top secret dei servizi. Dopo l’omicidio, quell’archivio sparì. Nessuno sa dove sia finito. Secondo alcune ipotesi, fu prelevato poche ore dopo la morte da uomini legati ai servizi segreti. Una bonifica mirata, per mettere tutto a tacere.
Secondo altri, alcuni documenti sarebbero stati distribuiti a colleghi fidati. Ma nessuno li ha mai visti.
Il delitto Pecorelli non è solo un cold case. È un simbolo. Un emblema di quanto potesse essere pericoloso, in quegli anni, cercare la verità. Giornalisti come lui, come Mauro De Mauro, come Walter Tobagi, hanno pagato con la vita la voglia di indagare là dove nessuno voleva guardare.
Ma Pecorelli, più di tutti, rappresenta il confine sottile tra l’informazione e il potere. Era un insider, un uomo che sapeva giocare il gioco sporco, ma che a un certo punto potrebbe averlo perso. Forse ha superato il limite. Forse qualcuno ha pensato che sapesse troppo. O, semplicemente, che parlasse troppo.
A distanza di oltre 40 anni, la sua morte resta un buco nero nella storia della Repubblica. E ogni tanto, qualcuno si chiede: cosa ci sarebbe scritto, oggi, in quell’ultima copia di Osservatore Politico, se Mino Pecorelli fosse riuscito a pubblicarla?