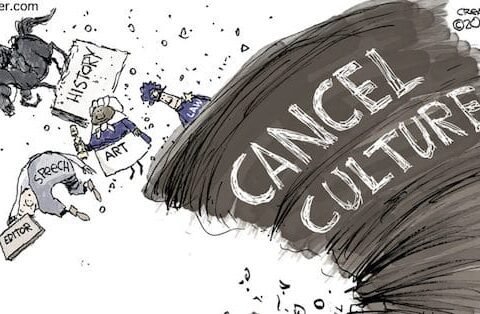Quando, poco dopo mezzogiorno, le luci si sono spente a Madrid, Lisbona e in decine di altre città iberiche, la reazione istintiva è stata il silenzio. Un silenzio carico di inquietudine. Nessun rumore nei binari della metro, nessun lampeggiare nei semafori. Solo qualche clacson stonato e la voce rauca delle radio d’auto ancora accese, a raccontare l’ovvio: mancava la corrente. E non era un guasto qualunque.
Per circa due ore, Spagna, Portogallo e parte del sud della Francia hanno vissuto una delle più gravi interruzioni elettriche degli ultimi decenni. Una vulnerabilità improvvisa e assoluta, che ha colpito infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, ospedali. E, più in profondità, la percezione stessa di sicurezza e affidabilità della rete elettrica europea.
Una crisi diffusa, e ancora senza un colpevole
Il blackout ha avuto un’estensione impressionante: dalla Galizia alla Catalogna, da Lisbona a Faro, passando per i Pirenei e fino ad Avignone. In totale, oltre 60 milioni di persone coinvolte. Le isole Baleari, Canarie, Azzorre, Madeira sono rimaste immuni, come spesso accade in questi casi: l’isolamento geografico si è rivelato un’ancora di salvezza.
Dalle prime ricostruzioni, l’interruzione sarebbe partita da un’interferenza lungo la dorsale elettrica che collega la Francia alla Spagna nei pressi di Perpignano. Un guasto, si ipotizza, innescato da un raro fenomeno atmosferico, forti escursioni termiche, anomalie nel carico di tensione o forse da un incendio che avrebbe colpito una delle linee ad alta tensione. Una spiegazione tecnica, sì, ma tutt’altro che rassicurante: se basta un rogo o un picco termico per paralizzare un continente, forse è il caso di rivedere le nostre priorità infrastrutturali.
Il gestore francese RTE, tuttavia, ha preso le distanze: nessuna anomalia registrata sul proprio lato della frontiera. Dall’altra parte, il portoghese REN parla apertamente di “fenomeno raro e imprevisto”, lasciando intendere che la causa potrebbe essere stata esterna al sistema nazionale. Madrid, dal canto suo, ha avviato un’inchiesta interna, mentre il governo evita di sbilanciarsi, mantenendo un profilo prudente. Forse troppo.
Tra autobus fermi e ospedali a rischio
Nel cuore di Madrid, il blocco ha colpito all’ora di punta. Metropolitane ferme, treni pendolari interrotti, semafori spenti. Centinaia di persone evacuate da convogli rimasti intrappolati nei tunnel. La rete ferroviaria AVE, orgoglio dell’efficienza spagnola, si è fermata come un orologio scarico. A Barcellona, oltre 50 treni hanno subito ritardi o cancellazioni. Scene analoghe a Valencia, Siviglia, Bilbao.
In Portogallo, l’aeroporto di Lisbona ha dovuto sospendere per un’ora le attività di check-in, mentre i generatori entravano in funzione. Nelle città, le reti mobili sono andate in tilt. Le comunicazioni si sono interrotte o rallentate al punto da rendere impossibile anche l’invio di un semplice messaggio WhatsApp. L’utilizzo di Internet, secondo i rilevamenti, è crollato al 17% rispetto alla norma.
Negli ospedali, il blackout ha mostrato il volto più cupo della crisi. A Madrid, il sistema di ventilazione automatica di alcuni reparti è andato in avaria per alcuni minuti. A Porto, la chirurgia d’urgenza è stata sospesa. Nessuna vittima accertata, ma l’equilibrio è stato sottile, mantenuto solo grazie alla prontezza di generatori e personale medico.
Tra ipotesi e omissioni
C’è un filo che unisce ogni blackout a ciò che non viene detto. Le prime 24 ore, come sempre, sono state un balletto di dichiarazioni prudenti e ipotesi vaghe. C’è chi ha sussurrato, senza prove, la parola “cyberattacco”. Nessun riscontro concreto. Ma la questione resta: quanto è vulnerabile la rete elettrica europea a un’azione malevola, organizzata e invisibile?
Nel frattempo, i governi fanno quadrato. Pedro Sánchez ha convocato un tavolo d’emergenza con Red Eléctrica e il ministero della Transizione Ecologica. António Costa, rientrato precipitosamente da Bruxelles, ha chiesto un’indagine indipendente. In Francia, l’Eliseo ha preferito tacere, almeno per ora. La sensazione è che la verità sia ancora in divenire.
Ripristino lento, memoria lunga
Il ritorno alla normalità è iniziato nel tardo pomeriggio, ma il recupero completo si è concluso solo nelle prime ore del 29 aprile. Alcune zone rurali del Portogallo centrale, secondo testimonianze locali, sono rimaste senza elettricità fino all’alba. Il danno economico non è ancora quantificato, ma si parla già di centinaia di milioni tra produttività persa, logistica bloccata e danni alle infrastrutture.
In molti, oggi, si chiedono se un blackout così esteso potesse essere previsto, o almeno mitigato. La risposta ufficiale, per ora, è no. Ma i dubbi crescono. L’Europa ha investito negli ultimi dieci anni miliardi nella digitalizzazione della rete, nella transizione ecologica, nell’integrazione interstatale. Ma proprio l’interconnessione, in questo caso, ha amplificato l’effetto domino. Un guasto locale è diventato continentale.
Una lezione per l’Europa
La fragilità emersa il 28 aprile non è un caso isolato. Negli ultimi anni, blackout localizzati hanno colpito anche Germania, Regno Unito, Italia. La novità, ora, è l’estensione e la simultaneità. Questo evento è destinato a diventare un caso di studio, anche per i suoi risvolti politici. Perché se la rete elettrica è la spina dorsale di un paese moderno, allora non può essere lasciata all’incertezza climatica o alle casualità ingegneristiche.
L’Unione Europea ha già convocato un vertice straordinario dei ministri dell’Energia per il 2 maggio. Sul tavolo, la creazione di un fondo per la resilienza energetica e un protocollo comune per la gestione delle emergenze. Parole importanti, ma non nuove.
Il blackout del 28 aprile non è stato solo un guasto elettrico. È stato un corto circuito simbolico, che ha mostrato quanto la nostra dipendenza dalla tecnologia sia fragile. Ci siamo accorti, per qualche ora, che sotto la superficie dei comfort digitali si nasconde ancora un’umanità vulnerabile, che senza elettricità torna a cercare candele, radio a batterie, e vicini di casa.
Aiutaci a far nascere il Progetto Editoriale LaLettera22, contribuisci alla raccolta fondi