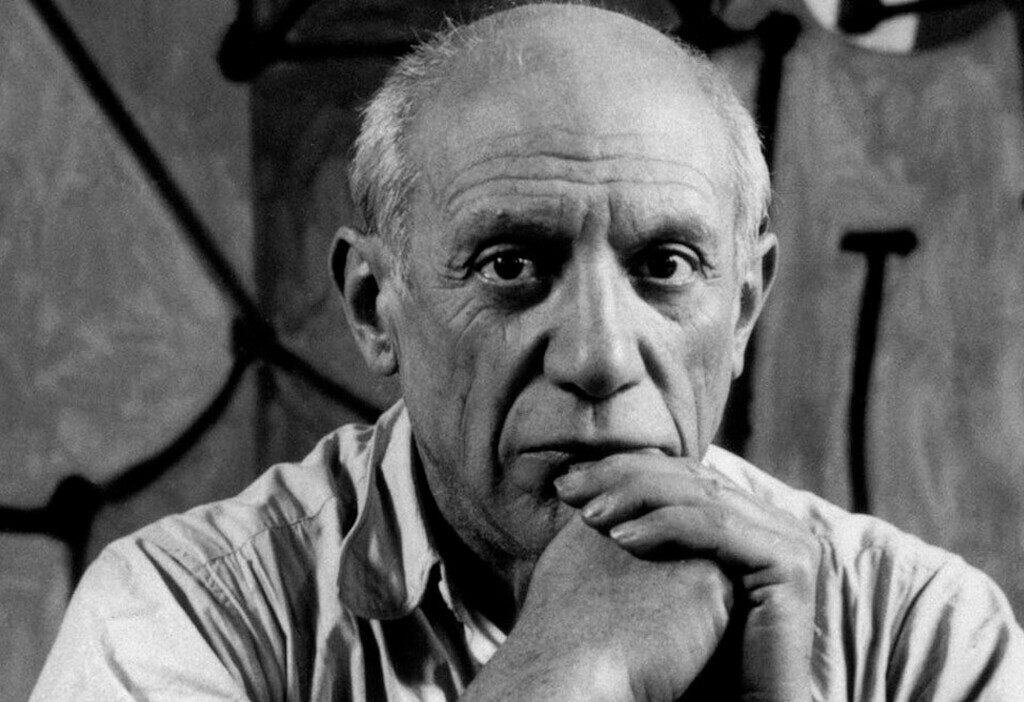Di fronte a ogni nuova crisi in Medio Oriente, l’opinione pubblica mondiale si spacca. Ma al di là delle reazioni emotive e delle posizioni ideologiche, c’è una verità storica complessa, fatta di migrazioni, promesse non mantenute, guerre e diplomazie fallite.
Capire come si è arrivati alla situazione attuale tra Israele e Palestina non è semplice, ma è fondamentale per orientarsi nel presente.
Le origini del sogno sionista
Alla fine del XIX secolo, l’antisemitismo si fece sempre più aggressivo in molte parti d’Europa. In risposta, alcuni intellettuali ebrei, tra cui Theodor Herzl, diedero vita al sionismo: un movimento politico che proponeva il ritorno in Palestina, la “terra promessa” della Bibbia, come rifugio sicuro per il popolo ebraico. Il nome stesso del movimento richiama “Sion”, una collina di Gerusalemme simbolo di salvezza e appartenenza.
Ma la Palestina di allora era tutt’altro che vuota. I territori, controllati dall’Impero ottomano, erano abitati prevalentemente da arabi musulmani, senza però una propria entità statale. Alla fine della Prima guerra mondiale, l’Impero ottomano crollò e le potenze europee si spartirono il Medio Oriente, disattendendo le promesse fatte agli arabi di autodeterminazione.
Il Mandato britannico e le tensioni crescenti
Nel 1917 la Gran Bretagna espresse il suo sostegno alla creazione di una “dimora nazionale” per gli ebrei in Palestina, con la Dichiarazione Balfour. Dopo la guerra, ottenne il Mandato sulla regione dalla Società delle Nazioni. Nella parte orientale istituì la Transgiordania (poi Giordania), mentre a ovest cercò di mantenere un fragile equilibrio: favoriva l’immigrazione ebraica ma prometteva anche di tutelare la popolazione araba locale.
In questo contesto, molti ebrei iniziarono a emigrare verso la Palestina. L’ondata si intensificò negli anni ’30, quando l’ascesa dei regimi fascisti e le persecuzioni antisemite spinsero migliaia di ebrei europei a cercare rifugio nella terra dei padri. Questo incremento demografico generò tensioni con la popolazione araba, che temeva di essere soppiantata.
Tra il 1936 e il 1939 scoppiò una rivolta araba repressa con durezza dai britannici. Nel frattempo, per placare gli animi, Londra limitò l’immigrazione ebraica. Ma poi arrivò l’Olocausto.
La Shoah e la nascita di Israele
La tragedia della Shoah, che costò la vita a sei milioni di ebrei, rese evidente l’urgenza di una patria sicura per il popolo ebraico. Dopo la guerra, la Gran Bretagna, logorata dalle tensioni, decise di rinunciare al controllo della Palestina e affidò la questione all’ONU.
Nel 1947 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Risoluzione 181: un piano di partizione che prevedeva la creazione di due Stati, uno ebraico e uno arabo, con Gerusalemme sotto controllo internazionale. Gli ebrei accettarono il compromesso. I palestinesi e i Paesi arabi no.
Il 14 maggio 1948, alla vigilia del ritiro britannico, la comunità ebraica (Yishuv) proclamò la nascita dello Stato di Israele. Il giorno dopo, gli eserciti di Egitto, Siria, Giordania, Libano e Iraq attaccarono, rifiutando la legittimità del nuovo Stato. Ma Israele resistette e si espanse oltre i confini stabiliti dall’ONU.
La Nakbah e la diaspora palestinese
Per gli ebrei fu l’inizio di una nuova era. Per i palestinesi, una catastrofe: la “Nakbah”. Circa 700.000 arabi furono costretti a lasciare le proprie case, molti finirono nei campi profughi e non tornarono mai più. Al tempo stesso, anche 700.000 ebrei furono espulsi dai Paesi arabi e trovarono rifugio in Israele.
Nel 1949, con gli armistizi firmati tra Israele e i Paesi arabi (ma senza veri trattati di pace), Israele ampliò ulteriormente i propri territori, conquistando Gerusalemme Ovest. Nel frattempo, la Giordania occupò la Cisgiordania e Gerusalemme Est, mentre l’Egitto prese la Striscia di Gaza.

Scontri, rivolte e nuove guerre
Le tensioni non si spensero. Nel 1956 Israele partecipò alla crisi di Suez al fianco di Francia e Regno Unito, in un tentativo fallito di colpire l’Egitto. Nel 1964, con il sostegno della Lega Araba, nacque l’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), decisa a cancellare Israele.
Nel 1967 scoppiò la Guerra dei Sei Giorni. Israele lanciò un attacco preventivo contro Egitto, Siria e Giordania, conquistando nuovi territori: Gerusalemme Est, Cisgiordania, Striscia di Gaza, alture del Golan e il Sinai. L’ONU chiedeva il ritiro e una pace duratura, ma senza successo. Nel 1973, durante la festività ebraica dello Yom Kippur, Egitto e Siria tentarono di riconquistare parte dei territori. Fu un conflitto duro, che portò a un blocco del petrolio da parte dei Paesi arabi, causando una crisi energetica globale.
Solo nel 1978, con gli Accordi di Camp David, Israele restituì il Sinai all’Egitto in cambio del riconoscimento dello Stato ebraico.
Guerra fredda e radicalizzazioni
La questione israelo-palestinese divenne anche un fronte della Guerra Fredda: gli Stati Uniti si schierarono con Israele, l’Unione Sovietica con gli arabi. Ma nessuna delle due superpotenze riuscì a controllare pienamente la situazione.
Negli anni ’80, Israele invase il Libano per colpire le basi dell’OLP. Intanto si fecero largo nuove forze: Hamas, fondamentalista islamica, nacque nel 1987 in contrapposizione all’OLP, allora orientata verso un compromesso.
Proprio nel 1987 scoppiò la prima Intifada, una rivolta popolare palestinese. Una seconda Intifada esplose nel 2000, con violenze ancora più gravi. Le speranze di pace, mai del tutto svanite, si scontravano con l’intransigenza delle ali radicali da entrambe le parti.
Un futuro ancora incerto
Oggi, la situazione resta drammaticamente irrisolta. Israele è una democrazia solida ma divisa internamente, dove le forze oltranziste hanno guadagnato sempre più spazio. I palestinesi vivono tra l’occupazione militare in Cisgiordania e il dominio di Hamas nella Striscia di Gaza, con uno Stato che non si è mai realizzato pienamente.
La “questione palestinese” è diventata un simbolo usato da molte potenze per fini propri. Dopo la fine della Guerra Fredda, nuove linee di tensione hanno attraversato il Medio Oriente: sunniti contro sciiti, potere politico contro spinte popolari, crisi economiche e minacce nucleari. Paesi come Iraq, Siria e Libia sono stati destabilizzati. Intanto sono emersi nuovi attori: la Turchia di Erdoğan e la Russia di Putin, mentre l’Unione Europea è rimasta marginale e gli Stati Uniti sembrano meno interessati all’area rispetto al passato.
Israele e Palestina restano il cuore pulsante di una ferita storica che non si è mai rimarginata. Due popoli, due memorie, due dolori che continuano a intrecciarsi sulla stessa terra. La pace, evocata mille volte, è ancora lontana. Ma la comprensione delle radici profonde di questo conflitto è il primo passo per non rassegnarsi all’eterno ritorno della violenza.