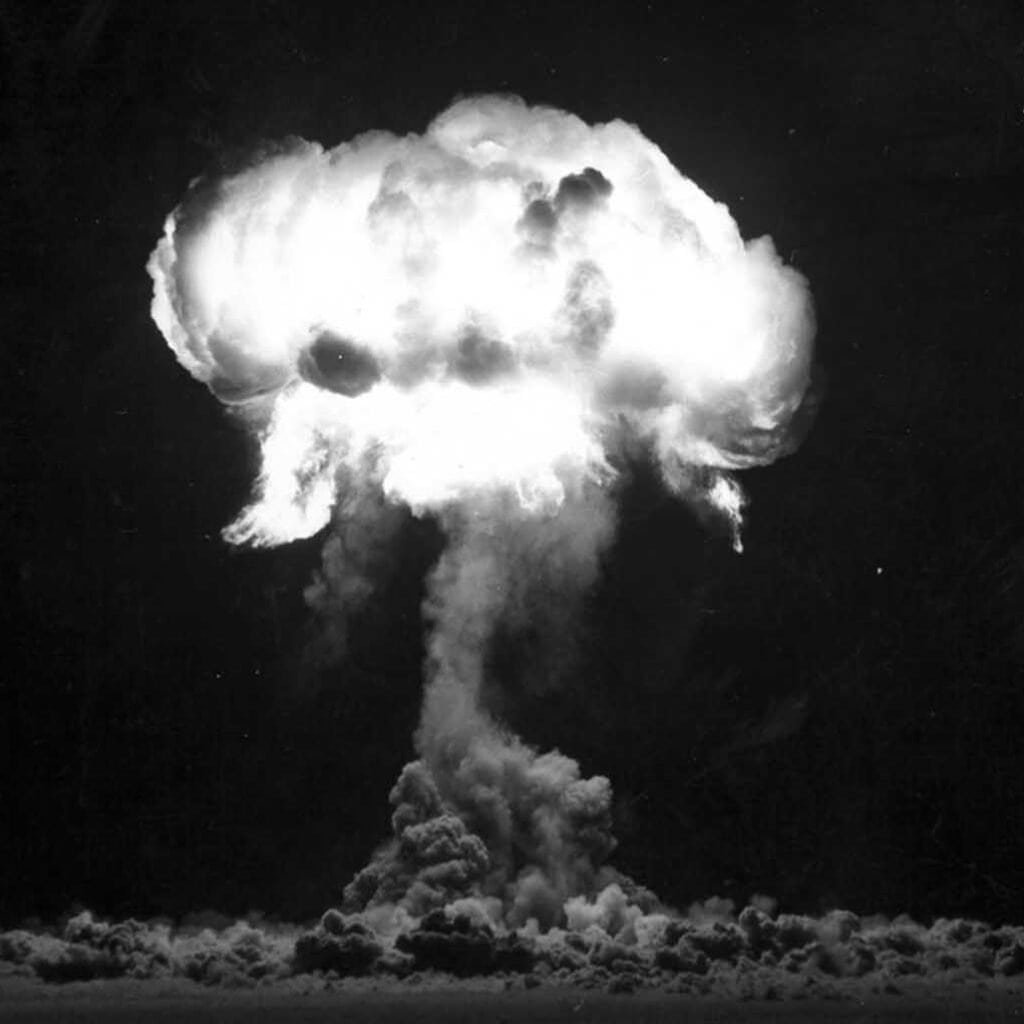Francesco Tesio si è dedicato allo studio di Gobetti fin dai tempi dell’università. Conseguita la laurea in Economia e commercio, lavora nel marketing e nella formazione di una grande multinazionale del settore metalmeccanico, continuando a coltivare la sua passione per i temi trattati da Gobetti. Oggi firma un brillante saggio: Piero Gobetti e l’economia. Il valore della rivoluzione liberale.
Piero Gobetti, uno dei maggiori organizzatori di cultura del XX secolo, fu originale anche nelle scelte di divulgazione dei grandi temi del suo tempo. Tra questi l’economia ebbe subito un posto da protagonista, sia per gli argomenti affrontati sulle sue riviste (specialmente «La Rivoluzione Liberale»), sia per i titoli pubblicati dalla sua casa editrice.
Per le sue analisi e per le sue scelte pratiche in politica, Gobetti parte dalle categorie economiche che aveva appreso da Luigi Einaudi, ma poi sviluppò un suo punto di vista personale e autonomo, riservando ampio spazio a molti pensatori innovativi su questioni allora non scontate, e facendosi egli stesso imprenditore ed editore.
A più di cento anni da quel momento cruciale per la storia d’Italia, Piero Gobetti appare ancora attualissimo nel suo approcciarsi all’economia, come parte essenziale del suo progetto di rivoluzione liberale. Chiediamo all’autore:
Come nasce questo suo spiccato interesse per il pensiero economico di Gobetti?
Le citerò un paradosso per un torinese: ho scoperto la figura di Piero Gobetti quando avevo vent’anni, frequentando un Circolo a lui intitolato a Milano. In seguito, ho approfondito negli anni dell’Università l’opera e le edizioni di Gobetti, scoprendo quanto l’economia fosse importante per lui, a partire dall’opera del suo Maestro Luigi Einaudi, professore di Scienza delle Finanze alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dove Gobetti si laureò. Per Gobetti l’analisi economica e la storia economica erano prerequisiti essenziali per realizzare il suo programma d’azione tratteggiato nel primo numero della Rivista La Rivoluzione Liberale, del 1922.
Nella presentazione al suo saggio, Silvia Berti racconta l’aneddoto in cui lei si chiedeva come mai sulle magliette dei giovani ci sia il volto di Che Guevara e non quello di Piero Gobetti: ce ne spiega il senso?
In effetti me lo ero chiesto alla fine degli anni 90 insieme a quegli amici del Circolo Gobetti di Milano e continuo ancora oggi a chiedermi, un po’ retoricamente forse, perché tanti ignorino chi sia stato Gobetti e che cosa abbia significato per l’Italia. Volgendola in positivo, mi augurerei che molti giovani si avvicinino a lui e si ispirino alla sua figura. Forse ci vorrebbe una fiction o una serie televisiva dedicata a lui e alla moglie Ada, per rompere l’incantesimo.
Cruciale appare, nel suo studio, la riflessione Gobettiana dell’assenza nella cultura economica italiana del “rischio imprenditoriale”. Gobetti diceva, infatti, “a un popolo di dannunziani non si può chiedere spirito di sacrificio”. Ritiene che sia ancora così?
Sono passati più di cento anni da quando Gobetti e i suoi illustri collaboratori scrivevano di temi economici sulla Rivista la Rivoluzione Liberale o pubblicavano testi di economia con la sua Casa Editrice. Non si può dire che il tempo sia passato invano certamente. L’Italia da Paese agricolo è diventato un rispettato membro del G7 anche non abbiamo modo qui di riassumere tutto questo. Tuttavia, se non vogliamo vedere i fatti in modo negativo, alcuni temi trattati rivestono un carattere di straordinaria attualità. Alcuni tratti del carattere nazionale su cui Gobetti si scagliava, con una lucidità e una capacità di sintesi straordinaria, sembrano non essere troppo cambiati, anche se la scala e la dimensione dei fenomeni si misurano oggi globalmente, nonostante i tentativi di qualcuno di reintrodurre per esempio i Dazi. Una misura che Gobetti e suoi sodali giudicavano già cento anni fa assolutamente improponibile. Estremizzando, ma non troppo, per Gobetti l’economia, come per Adam Smith, restava forse in fondo in fondo una branca della Filosofia Morale.
Giustizia e libertà, doveva essere la via Gobettiana verso una classe politica migliore, più consapevole dei problemi reali della classe operaia. E poi, cosa è successo?
Il glorioso movimento politico fondato a Parigi nel 1929, che Lei ricorda, è uno dei frutti dell’eredità gobettiana, anche se non è direttamente opera sua, ma dei suoi amici e sodali. Carlo Rosselli negli anni precedenti scrisse sulla rivista La Rivoluzione Liberale e collaborò con Gobetti. E va ricordato che la vedova di Gobetti, Ada Prospero, comandò negli anni della resistenza una brigata partigiana di Giustizia e Libertà in Val di Susa, ricevendo dopo la guerra il riconoscimento del grado di maggiore dell’Esercito, cinquantaquattro anni prima che le donne potessero diventare militari. L’eredità del Partito d’Azione, dopo il 1947, ha poi caratterizzato la vita politica italiana, grazie alla diaspora dei suoi esponenti nel Partito Repubblicano, in quello Radicale e in quello Socialista. Altro discorso, che meriterebbe anche uno spazio dedicato, è quello sull’analisi gobettiana dei fenomeni legati alla Classe Operaia nei primi anni Venti del secolo scorso. Nella gestione delle fabbriche occupate tra il 1919 e il 1920, i Consigli di Fabbrica rivelano -secondo il liberale Gobetti – una visione consapevole della necessaria manutenzione dei macchinari e del risparmio per il loro ammortamento. Tra alcuni dei Capi Reparto degli operai, Gobetti vede nascere una nuova elite, a cui gli Industriali attenti come Giovanni Agnelli guardano con rispetto e con cui riescono, abilmente, a porre fine all’occupazione, senza dover ricorrere ai mezzi deprecabili del Generale Bava-Beccaris di qualche decennio prima.
Aristocrazia operaia. Concetto che poteva applicarsi meglio all’atmosfera tipicamente settentrionale dell’impegno politico nelle fabbriche, piuttosto che meridionale. Quanto pensa che ciò abbia influito, più in generale, sull’atavica “questione meridionale”?
Nell’analisi dell’economia del suo tempo Gobetti pone molta attenzione al fenomeno dell’industria, elemento di modernizzazione importante per il Paese, ma è consapevole del fatto che l’Agricoltura è ancora il Settore Primario, non solo di nome, in Italia.
L’analisi delle diversissime condizioni dell’Agricoltura e di chi lavora la terra tra Nord e Sud (la mezzadria che permette il sorgere dello spirito imprenditoriale con la ricerca della modernità contrapposta al Latifondo e allo sfruttamento dei braccianti agricoli), spinge Gobetti a teorizzare un corollario del suo concetto di Rivoluzione Liberale: per l’Italia del Sud è necessaria quella “Rivoluzione Meridionale” (che è anche il titolo di un libro che Guido Dorso pubblica per la Casa Editrice di Gobetti) che riequilibri gli effetti di una riunificazione del Paese avvenuta frettolosamente, senza la partecipazione popolare che ci sarebbe stata in seguito solo con la Prima Guerra Mondiale e le sue determinanti conseguenze.
Da economista, avrebbe una ricetta per risanare la stasi odierna della nostra nazione? Magari un nuovo approccio risolutivo che passi da una nuova cultura economica degli italiani?
Come mero cultore della materia non posso sicuramente dare ricette, anche se mi ritrovo molto nelle recenti indicazioni che Mario Draghi ha dato alla Commissione Europea con il suo importante rapporto. Sicuramente l’analisi storica e l’opera di pedagogia economica a cui aveva pensato Gobetti con le sue Riviste e con la sua casa editrice, la cui sorte fu purtroppo segnata da un provvedimento di chiusura da parte del Regime fascista, mostra ancora oggi una sua spiccata attualità. E l’educazione finanziaria ed economica degli italiani merita ancor oggi una maggiore attenzione da parte delle istituzioni pubbliche e non, anche nella moderna componente dell’educazione al digitale.
La consapevolezza è il prerequisito per un autonomo esercizio del proprio potere decisionale da parte dell’elettore in una moderna democrazia. Da qui si deve ripartire se si vuole riportare alle urne quella metà del Paese che, secondo me sbagliando, ritiene di dare un segnale non recandosi alle urne.